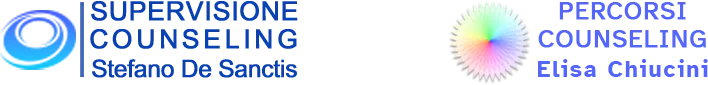La professione del padre

Un romanzo singolare, difficile da descrivere senza svelarne troppo.
L’inizio si può dire, perchè dalle prime pagine il quadro di un padre millantatore e violento, di una madre remissiva, di un figlioletto vittima, è chiaro.
Tutta la prima parte è densa di complotti, dell’amico americano Ted che dà istruzioni al padre a che a sua volta le trasmette al figlio o se ne fa scudo per le punizioni tremende che infligge al piccolo protagonista quando non esegue a puntino gli ordini o non è perfetto a scuola.
Pian piano il figlio diventerà parte attiva e proattiva dei deliri del padre. Diventerà grande, si costruirà una vita autonoma: un bel lavoro di restauratore, una moglie, un figlio.
Stavo per lasciarlo a metà, stanco della sequenza di “avventure” senza costrutto. Avrei fatto un grande errore, perchè la prima parte è stata necessaria a preparare una seconda parte bellissima, nella ripresa di contatto dopo anni del figlio con i genitori.
Di questa parte preferisco non dire niente, se qualcuno che leggerà qui vorrà leggere il romanzo, perchè l’ho letta non più stancamente come fin verso la metà ma appassionato e voglioso di arrivare alla fine dello svolgimento dei sentimenti che si sviluppano.
Senza le grandi contraddizioni che mi sarei potuto aspettare, e anzi con un tono piano, equilibrato, mai urlato. Commovente. Un sentimento che per qualche verso si avvicina a quello che ho avvertito nel vedere Joker, per la vicinanza, che in nessun modo copre le pessime azioni dei protagonisti, a stati di sofferenza estrema di alcune persone. DA LEGGERE
Tutto chiede salvezza

Una settimana di TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) trascorsa da Daniele Mencarelli – il personaggio del romanzo ha lo stesso nome dello scrittore – in una stanza a sei letti del reparto di psichiatria di un ospedale, dopo l’ultima esplosione di rabbia che, oltre a distruzione di oggetti, ha prodotto ferite alle mani e lo svenimento del padre.
“Mi sembra che la vita mi pesi più degli altri”, dice Daniele, vent’anni, allo psichiatra. La sua ricchezza e la sua condanna è un’empatia priva di confini, che può diventare distruttiva.
Si alternano, nei colloqui, due psichiatri, uno assente l’altro più partecipe. Alla fine le parti quasi si invertiranno: il primo risolverà con inaspettata umanità una situazione molto difficile mentre l’altro si sarà rannicchiato in fuga da tutto.
Questa capacità di restituire, con poche pennellate chiare, la complessità e le contraddizioni di tutti i personaggi presenti a me pare una delle qualità migliori del libro.
Nelle sette giornate che Daniele trascorre lì, in un periodo di caldo afoso che rende a tutti difficile dormire e che fa svegliare inzuppati di sudore, Daniele conosce i compagni di stanza.
Due sono lì come lui in TSO, per poco tempo, finchè non passa il momentaccio; altri sono fissi, chi del tutto privo di sguardo e di mondo, chi alle prese con un passato irredimibile.
Poi ci sono gli infermieri. Ciascuno merita un ritratto non banale, non stereotipato; ognuno, anche chi appare di straforo o del tutto sullo sfondo, viene restituito con pochi tocchi che ne rendono la complessità.
Ci sono mezze pagine – la gravidanza “impossibile” fra due pazienti – che in poche righe alternano il sapore di pezzi di paradiso allo sprofondo nella realtà.
È un libro pieno di emozioni vere, che prendono chi legge proprio perchè le sente vere, mai strumentali alla storia da raccontare.
“La gratitudine che Mario sa restituirmi dovrebbero vederla almeno una volta nella vita tutti gli esseri umani esistenti. Come un’opera d’arte o un capolavoro della natura.”
Il padre e la madre di Daniele, i fratelli, li vediamo in controluce: una base sicura che gli permette di non perdersi del tutto. Forse pure che gli ha permesso di sperimentare lo sperimentabile nella certezza di ritrovarli: sempre, solidi.
Sul finale, un incidente: sono bastate meno di dieci righe a renderne la drammaticità.
A seguito dell’incidente, le reazioni emotive varie dei pazienti producono una scena in cui ciascuno rivela altre parti di sè. Bastano quattro pagine, senza alcun bisogno di calcare la mano su qualche effetto, a far succedere tutto e a restituire a ciascuno una collocazione.
La settimana di TSO finisce, Daniele torna a casa a piedi, immerso nella gioia dei colori intorno, dove tutto chiede salvezza.
Sono molto contento che sia entrato nella cinquina finalista dello Strega e che sia stato il più votato dai giovani. Della cinquina (sestina, quest’anno) ho letto Colibrì, mentre non conosco gli altri libri finalisti. Visto che il libro di Veronesi è stato il più votato dalla giuria che assegnerà il premio, non ho dubbi che Mencarelli meriti di vincerlo.
Un’ultima riflessione, simile a quella fatta dopo aver letto il suo primo romanzo: a un certo punto gli spunti tratti dalla vita di una persona si esauriscono, o si ripetono; auguro a Daniele Mencarelli di continuare a regalarci questa prosa anche con altri protagonisti.
A proposito di niente
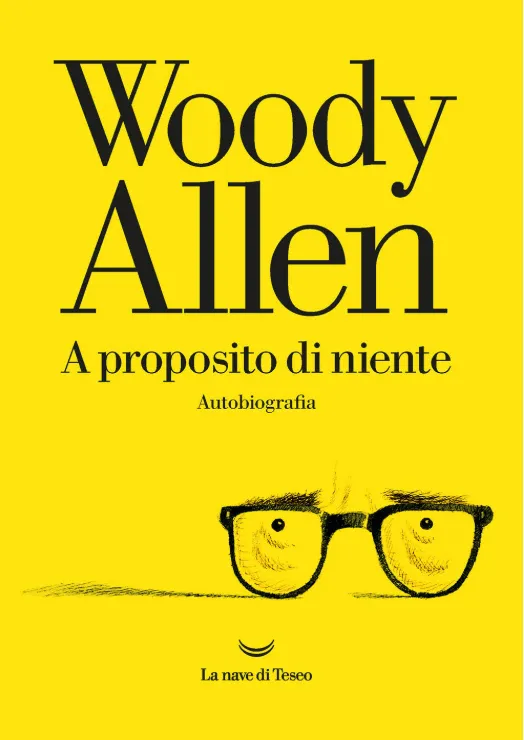
Quattrocento pagine di autobiografia che vanno dagli inizi – quindicenne – come scrittore di battute vendute a una società di promozione che li attribuiva a personaggi famosi della politica, dello sport, dello spettacolo fino agli ultimi film.
Mi ha fatto venire voglia di recuperare i pochi film che non ho visto e di rivedere i tanti che ho visto. Sono tutti, senza eccezione alcuna, film che è valsa la pena vedere e non ce n’è uno che non offra, oltre al divertimento, qualche spunto di riflessione esistenziale, ottima musica classica e citazioni colte anche se buttate là come se non lo fossero. Autobiografia più film restituiscono una persona che ha capito come funziona il mondo, che soffre delle ingiustizie ma non se ne meraviglia, così come non si meraviglia delle giravolte sentimentali di noi umani e che attribuisce al caso il principale peso di ciò che viviamo.
In mezzo, anche qualcosa sulla vita privata e sulle accuse che ha subito. Non c’è niente di pruriginoso, preferisco affidarmi alla riconstruzione che ne ha fatto “Il Post”. https://www.ilpost.it/…/woody-allen-accuse-violenze…/
Da parte mia trovo ignobile che l’editore Usa abbia rinunciato alla pubblicazione di questo libro così come il boicotaggio degli ultimi film e mi limito a due osservazioni: il matrimonio in corso dura da venticinque anni, alla coppia sono state date due bambine in adozione.
Nel libro sono citati credo tutti coloro che, nelle posizioni più diverse, lo hanno accompagnato nella lunga vita professionale e per ciascuno c’è almeno una parola di apprezzamento.
Tanti elogi anche per gli attori e le attrici: più d’una ha vinto Oscar con i suoi film e molte sono state candidate. I film corrispondono al personaggio che emerge dal libro: pieno di paure e ossessioni e tuttavia con una voglia di vivere smisurata – “io sono contrario alla morte” – che si realizza negli affetti quotidiani e nella produzione di sceneggiature – tutti i film sono “scritto e diretto da Woody Allen” – e regie dove è facile immaginare che rielabori fantasie e vissuti propri e di chi gli sta intorno.
Credo sia sincero quando, in conclusione, scrive “ho avuto milioni per fare film in totale libertà, e non ho mai girato un capolavoro”. Lo posso condividere: nessuno dei suoi film, da solo, è un capolavoro. Ma nessun regista al mondo ha girato più di cinquanta film – una media di uno all’anno – che vale la pena vedere, senza eccezioni.
Il finale di “Basta che funzioni”:
“Qualunque amore riusciate a dare e ad avere, qualunque felicità riusciate a rubacchiare o a procurare, qualunque temporanea elargizione di grazia: basta che funzioni. E non vi illudete.
Non dipende per niente dal vostro ingegno umano. Più di quanto non vogliate accettare, è la fortuna a governarvi: quante erano le probabilità che uno spermatozoo di vostro padre tra miliardi trovasse il singolo uovo che vi ha fatto? Non ci pensate, sennò vi viene un attacco di panico.“
Almeno una cosa (ultima pagina del libro) ce l’ho in comune con Woody Allen: “Il mio eroe preferito? Il cavaliere della valle solitaria”
Ogni coincidenza ha un’anima

Il protagonista si è inventato un lavoro che a quanto pare gli funziona: ascolta i bisogni di persone che gli si rivolgono e prescrive loro libri.
Arriva la figlia di un grande intellettuale, malato ora di alzheimer, gli chiede di capire, in base a pochissimi indizi lasciati dal padre, di quale libro possa trattarsi.
L’impresa sembra impossibile, ma il nostro è sagace e fortunato.
Se troverà il libro ed eventualmente come utilizzerà il ritrovamento o il non ritrovamento non lo scrivo, perchè è questo il filo, tenue ma bel sviluppato, delle duecento cinquanta pagine – quelle piccole formato Sellerio – del libro.
I personaggi che si alternano nello studio del biblioterapeuta servono a intervallare la storia principale che altrimenti sarebbe poca cosa; sono ben descritti, vivaci, ma del tutto inessenziali alla storia e un po’ fastidiosamente orientati a farci sapere come la pensa l’autore del mondo.
Anche i tanti libri citati – ce ne viene offerto l’elenco in appendice – mi hanno dato l’impressione che l’autore si sia messo davanti alla sua biblioteca e abbia scelto ciò di cui gli piaceva scrivere.
La storia è comunque gradevole e molto ben scritta, scivola via leggera con un finale grazioso e inesorabilmente political correct.
Karoo

Karoo è uno sceneggiatore di grande successo: i suoi interventi sono considerati miracolosi nel riuscire a rimettere in piedi un film zoppicante, nel far diventare un grande successo quella che poteva essere una storiella, nel rendere almeno accettabile qualcosa di penoso.
Per qualche mistero della chimica e della fisica, a un certo punto della sua vita Karoo può bere senza limite e senza ubriacarsi ma, siccome tutti lo conoscono come “uno che beve”, finge ogni volta di essere ubriaco per compiacere gli interlocutori e non indagare oltre circa il suo corpo.
La caratteristica principale di Karoo è la mancanza di un bypass fra se stesso e la realtà.
Questo può essere osservato attraverso due, complementari, modalità comportamentali: in certe circostanze sa esattamente che cosa davvero vuole ma agisce altrimenti; in altre, sa esattamente che cosa l’altro si aspetta da lui, glielo promette, glielo giura, e fa regolarmente altro.
Karoo, in effetti, riscrive continuamente la sceneggiatura della sua vita.
Con la quasi ex moglie, che lo conosce a fondo e lo svela senza pietà – il capitoletto che parte da pag. 282 è un capolavoro a se – ha un divorzio in corso senza che si facciano veri passi avanti.
Al figlio adottivo poco più che ventenne, che si ostina a voler credere alle promesse del padre, continua a rifilare buche clamorose.
Va, solo perchè vuole pubblicamente sbranarlo per le sue note nefandezze, all’appuntamento con il feroce produttore di Hollywood, e si ritrova sedotto e coinvolto nello scempio dell’ultimo capolavoro, di cui riconosce la grandezza artistica, del famoso regista, morente.
Nel flm del famoso regista gli sembra di individuare qualcosa che lo induce a mettersi alla ricerca della madre naturale del figlio. Le vicende che seguiranno, dove la mancanza di bypass fra sè e la realtà produrrà situazioni fra il tragico, il divertente, lo squallido, l’inverosimile, sono il clou del romanzo.
Gli avvenimenti saranno tali che un famoso giornalista decide di scriverci un articolo, va alla ricerca dei protagonisti, di chi li ha conosciuti e li conosce, e il risultato è tale che “con un minimo di allenamento ce l’avrebbe fatta a diventare anche in privato, ai suoi stessi occhi, la persona che era ritenuta in pubblico.“
Il finale è degno del personaggio, che ha tanti di quei lati pessimi che non possiamo fare a meno di provarne compassione, mista a un pizzico di simpatia per la sua vitalià inesauribile.
Vita e morte di un ingegnere

Scritto subito dopo “La scuola cattolica“, e da me letto subito dopo, è come se fosse una continuazione. Come se dopo aver esplorato un quartiere borghese, una scuola privata, un delitto che in quell’humus ha preso forma, Albinati abbia deciso di andare in profondità nella vita del padre.
L’autore scrive ancora in prima persona, è lui presente, non si tratta di un romanzo, si tratta della descrizione del padre, del quasi non rapporto con quest’uomo dedito al lavoro, del quale la moglie spera che l’avvicinarsi della morte “porti a galla i tesori sepolti… senza capire che il tesoro era appunto quell’acqua limpida… in fondo alla cui singolare trasparenza non c’era niente che non fosse da sempre visibile a occhio nudo”.
Mi sono chiesto se mi piacerebbe risultare così a un figlio e no, non mi piacerebbe: quella “singolare trasparenza”, che pure fa pensare a una persona “pulita”, senza contraddizioni, la sentirei addosso come un limite.
Il libro – 159 pagine – è diviso in due parti, quasi paritarie, ma anche se della malattia e della morte si tratta nella seconda parte, malattia e morte sono presenti in tutto il racconto.
A me è rimasta impressa con forza la descrizione puntigliosa, dotata di una pietas tenuta a bada da un intelletto poco incline alle sbavature emotive e che tuttavia arriva al lettore, che si chiede – io mi chiedevo – ma ne avete tutte le possibilità, perchè non lo fate morire in pace?
La risposta ci viene data, anche se la domanda nel testo non è posta, e sono quei piccoli gesti che possono essere scambiati, senza poterne essere certi, per attaccamento alla vita, e ai quali non può essere negato valore.
Accompagnamo così l’ingegnere nelle riprese, nelle ricadute, in alcuni trattamenti quasi sicuramente inutili, talvolta dolorosi oltre che inutili, funzionali probabilmente solo al profitto della clinica, fino alla morte nel letto di casa, con i cari vicini ma senza che riesca a godere della loro presenza mentre qualcuno, di sicuro l’autore, cerca, e forse riesce, a beneficiare fino all’ultimo respiro del padre, anche se non sembra riuscire a riconoscerne il sapore.
Difficilmente saremo sollevati dal doppio arcobaleno che si staglia sulla Flaminia mentre la famiglia torna a casa dopo la cremazione.
LACCI
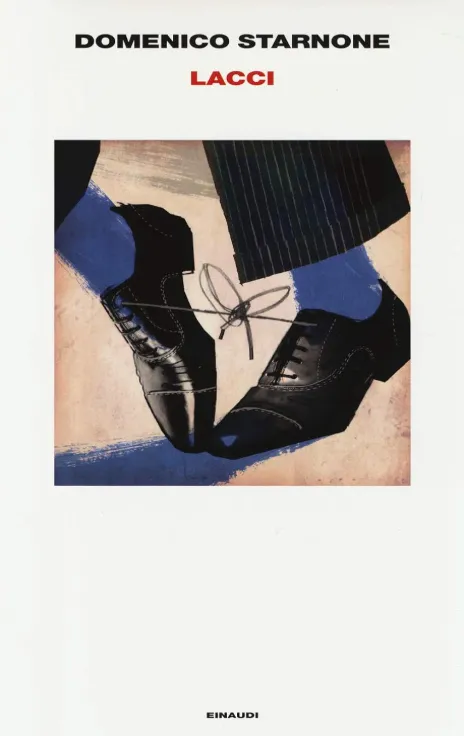
Lo capisco, definirlo “disperato” può non attrarre, e tuttavia vale la pena leggere questo ultimo romanzo di Domenico Starnone.
Ne lessi, e rilessi – uno dei libri più divertenti che io abbia incontrato – “La scuola”, agli esordi, poi uno o forse due altri romanzi che non mi hanno lasciato traccia; questo “Lacci”, invece, mi ha colpito per il pessimismo cosmico che trasmette, vestito di uno stile sempre accattivante e piacevole.
Una coppia va in crisi: lui si è innamorato di una ragazza più giovane e vuole viversi questa esperienza. Niente di più banale, eppure i bei romanzi non sono dati dal raccontare storie nuove, ma dal come vengono raccontate. E Starnone sa raccontare, sa tenere l’attenzione viva, la curiosità sveglia.
Ci saranno evoluzioni, naturalmente, che qui non racconto.
Ci sono, oltre a marito, moglie, amante di lui, due figli, che da bambini patiscono l’assenza del padre e da adulti si confrontano sulle identità dei genitori, e infine un gatto, con un suo ruolo nella narrazione.
Benchè il finale sembri aspirare a trasmettere un senso di vitalità e spensieratezza, non si salva nessuno. L’impressione è che l’autore non li sopporti proprio, i suoi personaggi, come se il suo approccio allo stare al mondo avesse esaurito tutte le energie a cercare di capirlo e ci avesse rinunciato, senza essersi arreso al fatto che, “capire”, non si può.
“Se tu te lo sei scordato, egregio signore, te lo ricordo io: sono tua moglie“.
Questo è l’incipit “Ti mostri affettuoso e intantio sfoghi i cattivi sentimenti per vie traverse“, dice la moglie del marito.
“Mio fratello è un uomo finto… sa mimare bene tutti i sentimenti senza mai provarne nessuno”, dice la sorella del fratello, da adulti.
I VAGABONDI
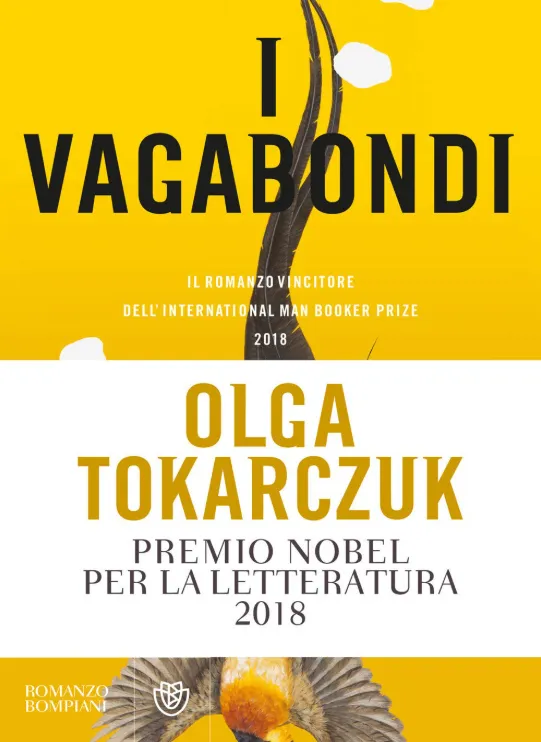
Non è un romanzo, ma poco importa. D’altra parte nemmeno lo si sarebbe potuto definire una raccolta di racconti, anche se ci sono dentro almeno due, tre racconti molto belli.
Una serie di impressioni di viaggio fra aeroporti, treni, incontri occasionali, metropolitane.
Eppure l’autrice riesce, e senza fornire appigli di collegamento, a mantenere amalgamate le storie che racconta. Oltre al tema del viaggio, la conservazione dei corpi dopo la morte: il cuore di Chopin trasportato dai suoi amici; lo schiavo nero diventato il confidente saggio dell’imperatore e, dopo morto, le struggenti lettere della figlia all’imperatore, affinchè cessi quella barbarie di esporlo impagliato come un fenomeno; la donna che vaga per la metropolitana e incontra una barbona che ha una sua storia; moglie e figlio che scompaiono per due giorni durante una vacanza e, anni dopo, il marito/padre che ancora chiede alla moglie come sono andate le cose.
Sarei molto curioso di sapere come ha deciso l’ordine in cui ha disposto i capitoletti.
Per esempio, il racconto più lungo, di moglie e figlio che scompaiono, è esposto in tre parti diverse, riconoscibili dallo stesso titolo: prima dieci pagine e poi altre sedici con in mezzo solo un paio di capitoletti di mezza pagina, infine ripreso duecentocinquanta pagine dopo. Perchè duecentocinquanta e non cinquanta o cento o duecento? E tutti gli altri “titoli”, piuttosto brevi, ha un senso che siano collocati dove stanno o è puramente casuale?
Già porsi queste domande esclude che di romanzo possa trattarsi e che abba una struttura. Eppure, chiamatelo come vi pare ma leggetelo, perchè ne vale la pena.
L’autrice ha originariamente studiato psicologia e qui si è inventata una “psicologia del viaggio” che fa capolino qui e là fino alla fase chiave: “qualunque sia la destinazione, si viaggia sempre in quella direzione. Non importa dove sono, non fa differenza. Io ci sono.”
Diceria dell’untore
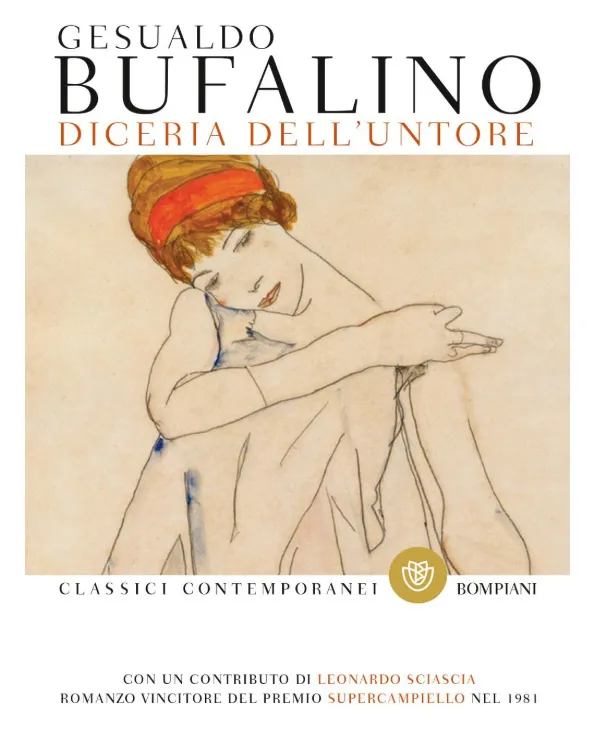
Per leggere un libro di Bufalino bisogna innamorarsi della sua scrittura. Me ne sono innamorato con “Le menzogne della notte”,
ed ecco qui il più famoso “Diceria dell’untore”.
È una storia, se vogliamo banale, di un amore e di competizione per una donna all’interno di un sanatorio per malati di tubercolosi. Qualcuno morirà, qualcuno è già morto e non lo sa, o lo sa, qualcuno si salverà.
Qualche assaggio, perchè non riuscirei a renderne la grandezza.
“Si scambiavano frantumi di suono, una poltiglia di sillabe balbe rimasticate in eterno da mascelle senili”
“Il sole sbocca dai tetti, grondante tuorlo, orrido mestruo del cielo. Il soffio che ne nasce non fa nemmeno sudare, ma stringe dentro un pugno il cuore, scaglia le rondini a rompersi contro la sciara, dovunque fa mulinello, e le illude, un inesistente palpito d’acqua.”
“Avevo più letto libri che vissuto giorni, nel mio così fuggitivo, così inefficace passaggio lungo le stradde degli uomini.”
“Voglio cercarmi un bambino per la strada… Gli darò uno schiaffo, gli dirò un’oscenità, una bestemmia di quelle che non si scordano. Voglio durare cinquant’anni ancora dentro di lui.”
“… nei miliardi di secoli passati e futuri io non so trovare evento più importante della mia morte.
E tutte le carneficine e derive di continenti e scoppi di stelle sono soltanto canzonetta e commedia al confronto di questo minuscolo e irripetibile cataclisma, la morte di Marta. Cosa non farei per ritardarlo di un attimo. La puttana, la spia, l’aguzzina. E chissà che non l’abbia già fatto.”
In generale, non amo questo tipo di scrittura ridondante, non vorrei mai scrivere così.
Ma dalla scittura di Bufalino sono affascinato, come da un gorgo che ti attira e non ti lascia.
Il libro varrebbe la pena averlo, per chiunque scriva, anche solo per l’appendice finale, aggiunta in questa edizione: c’è l’indice dei “Temi”, fatto dall’autore, c’è la spiegazione delle scelte di scrittura, ci sono note quasi per ogni pagina. Non per caso lo cominciò a scrivere negli anni cinquanta e fu pubblicato nel 1981. Per me, un grande della nostra letteratura.
L’angoscia del re Salomone

Questo romanzo, come il precedente “La vita davanti a sè“, uscì firmato da Emile Ajar. Con questo stratagemma Roman Gary vinse per due volte – il regolamento lo avrebbe vietato – il premio Goncourt. Si dev’essere divertito un sacco, visto che il segreto è riuscito a portarselo nella tomba.
Come nel precedente, il protagonista è un outsider, che parla una lingua tutta sua con la quale pronuncia inconsuete verità:
Jeannot è stato ingaggiato da Salomon, un vecchio di ottantacinque anni, ricco di trascorsi industriali, come tutto fare; Salomon sostiene un centro – una sorta di telefono amico – e qualche volta è lui stesso la notte, a rispondere alle telefonate dei disperati, perchè, dice Jeannot, “la notte si sente maggiormente angosciato e appunto quando è più solo ha bisogno di qualcuno che abbia bisogno di lui.”
Sembra aver imparato la lezione che Salomon gli ha dato quando si sono conosciuti: “… che si sono sempre sentiti sfigati e respinti e che si rifanno diventando psichiatri e si occupano dei giovani drogati e dei poveri disgraziati e si sentono importanti e sono molto ricercati e circondati da ammirazione…“
La vicenda centrale è tuttavia una triangolazione che si snoda, con la mediazione del centro di assistenza telefonica, fra Salomon, Jeannot e Cora, una anziana cantante che ha avuto un breve momento di gloria negli anni della guerra.
Scopriremo strada facendo perchè Cora non ha potuto proseguire una carriera che sarebbe potuta essere importante, scopriremo quale relazione c’è stata fra Salomon e Cora, quali segreti nasconde, vedremo quali saranno i modi, in parte casuali, in parte orientati, con i quali Jeannot e Cora si avvicineranno. Un libro delizioso.
Il clan dei Mahé

Una gran fatica, arrivare alla fine.
Sconcertante.
A voler trovare un tema, un senso: un medico trascinato da una passione che nemmeno è una passione per una adolescente appena intravista con la quale nemmeno parlerà mai.
Una vita monotona che trova un’occasione per rigirarsi… sì, le atmosfere sonnacchiose di una provincia francese umida, ma che altro?
Mi ha veramente detto poco, ma forse sono io a non aver trovato.
DUE VITE

Premio Strega 2021, centoventi pagine che scorrono, letto in un pomeriggio.
Non conoscevo, prima di leggere questo libro, nè Rocco Carbone nè Pia Pera….
Di un amico – scrittore – e di un amica – traduttrice – dell’autore, morti prematuramente.
Purtroppo, la letteratura sopravanza la vita.
Questa è l’acqua

Mi rendo conto, a distanza di una decina di giorni da quando ho finito di leggerli, che di nessuno ricordo la trama.
Di tutti ricordo i personaggi, le atmosfere, le situazioni.
I racconti di David Foster Wallace una trama ce l’hanno: è che a me è rimasto impresso altro: una scrittura movimentata, allusiva e descrittiva insieme. Con tutta la gamma dall’ironia al sarcasmo.
Ecco qua: “Onassis, sul suo yacht …. rimugina davanti a un succo di sedano nell’angolo bar, seduto su uno sgabello di teak. Il sedile dello sgabello e la superficie del bancone sono rivestiti di raffinatissima pelle grigiazzurra ricavata dallo scroto di capodoglio sotto la supervisione personale della signora O. Onassis gira i cubetti di ghiaccio con il grosso dito.”
Da rileggere, prima o poi.
APPREZZABILE
Trilogia di New York

Mi fu regalato tanti anni fa, appena uscito. Lo lessi e oggi ne ho solo un ricordo confuso.
Mi dovette piacere, perchè subito dopo lessi, sempre di Paul Auster, “La musica del caso”, che invece ricordo piuttosto bene.
Più di recente ho letto Baumgartner, il suo ultimo romanzo, e così, quando me lo sono trovato davanti, in libreria, ho deciso di rileggere “Trilogia di New York”, che è come se mi fosse rimasto qualcosa di irrisolto.
E, infatti, mi toccherà stare molto attento, perchè nelle prime cinque pagine sappiamo che il protagonista, Quinn, è uno scrittore che ha lasciato la buona letteratura e che ormai per vivere scrive gialli seriali, uno all’anno. Quinn scrive con lo pseudonimo di William Wilson e si è ormai immedesimato in Max Work, l’investigatore privato protagonista dei romanzi di William Wilson.
E così siamo già a tre protagonisti potenziali, quando alla voce narrante arriva una telefonata di qualcuno che vuole parlare con l’investigatore privato Paul Auster.
Sono molto curioso.
La vita è altrove

Un romanzo che segue la breve vita di Jaromil, il poeta convinto di essere capace di costruire una coerenza fra il lirico e il rivoluzionario, nella Praga degli anni quaranta, mentre si afferma il “socialismo” di marca sovietica.
Le donne di Jaromil, con l’eccezione della madre, non hanno un nome: sono la rossa, la cineasta. Anche gli uomini è più facile ricordarli come il pittore, il poeta sessantenne, il poliziotto figlio del bidello, e alla fine, per il lettore, Jaromil sarà solo “il poeta”.
Sono “tipi” non tanto dell’epoca quanto dell’umanità, maschere a contorno di una vita di quelle – come, forse, sono un po’ tutte le nostre vite – che si vogliono gloriose e che, se non ci fossero state, nessuno se ne sarebbe accorto, se uno scrittore non avesse deciso di scriverne in un romanzo.
D’altra parte, se “…l’uomo non può in alcun modo saltar fuori dalla propria vita, il romanzo è molto più libero.”
Negli ultimi due capitoli il punto di vista sui personaggi cambia, eppure li riconosciamo tutti, nelle ultime pagine feroci e tenerissime.
Come tutto Kundera.
La sovrana lettrice
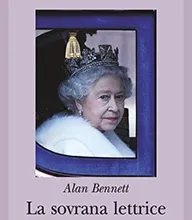
Grande preoccupazione a corte: la regina, vicina agli ottanta, ha cominciato a leggere libri!
Non che questo la distolga da suoi doveri, non che la induca a comportamenti inappropriati, tuttavia, nell’entourage, cercano rimedi.
Ne trovano di provvisori, come far scomparire qualche addetto a cui la regina si è forse affezionata, anche se la sua regale posizione non le permette nemmeno di cercarlo.
Il primo ministro si tranquillizza e immediatamente dopo si turba quando la regina fa sapere, in occasione della festa per gli ottanta, che ha intenzione di passare dalla lettura alla scrittura: non di viaggi, nè di un memoire, forse di un saggio e, chi lo sa, forse di un romanzo, perchè no.
Il primo ministro è sbiancato, e non ha ancora letto l’ultima riga di queste deliziose cento pagine di Alan Bennet, sempre soave e pungente.
La vegetariana

Il romanzo – 176 pagine – è diviso in tre parti: nella prima il protagonista è il marito, nella seconda il cognato, nella terza la sorella.
Marito, moglie, sorella di Yeong-hye: la vegetariana.
Il titolo può trarre in inganno, da qualche parte ho letto commenti insensati del genere “hai visto che succede a non mangiare più carne?”.
Si tratta della storia della follia di una donna, che parte da alcuni sogni spaventosi. Ma l’autrice non vuole condurci nell’abisso che può aver prodotto quei sogni e i comportamenti succesivi, si limita a mostrarci il baratro del presente e come se ne varca, inesorabilmente, la soglia.
La scrittura è “povera”; mi sono interrogato sulla difficoltà di tradurre dal coreano, ho cercato in giro e ho scoperto che in realtà il testo italiano è una traduzione della iniziale traduzione inglese, a quanto pare fonte di forti polemiche in Corea e non solo.
Ho immaginato di poter leggere la seconda parte, di gran lunga la più bella, in originale e mi è piaciuto convincermi di come – forse – sarebbe stato visionario il movimento di due corpi dipinti di fiori mentre fanno all’amore, uno coinvolto allo spasimo e l’altro partecipe per inerzia. Una specie di violenza consensuale, se mi si passa l’ossimoro.
Inquietante. Peccato non conoscere il coreano: ho provato con i film di Kim-Ki-Duk (da non perdere) sottotitolati ma temo non sia sufficiente
La banda dei brocchi
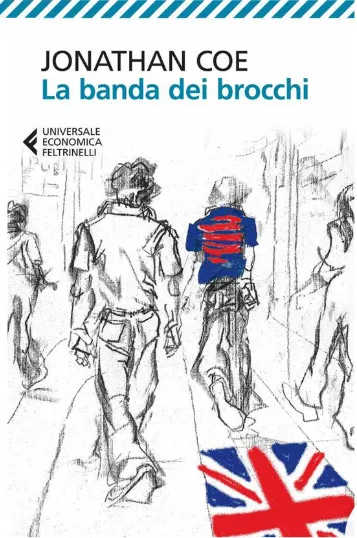
Sono le storie di un gruppo di ragazzi nel periodo delle scuole superiori, con intermezzi che coinvolgono i rispettivi genitori e insegnanti.
Si è fatto leggere, ma arrivare alla fine è stato faticoso.
Il decoro

Lo stato di totale smarrimento di un gruppo di amici newyorkesi, intellettuali più che benestanti anche se non straricchi, dopo la vittoria di Trump.
La casa del sonno

La costruzione dell’intreccio è magistrale.
L’alternarsi di capitoli pari e dispari a vent’anni di distanza, con tutti i fili al posto giusto e senza mai lasciare il lettore disorientato è affascinante.
Eppure, l’emozione, quando potrebbe prenderti, resta sospesa, perchè quella che appariva una storia drammatica non capisci più bene se non sia invece virata nel grottesco.
Nei corsi di sceneggiatura si insegna che in una storia una coincidenza ci può stare, due diventano sospette, tre rendono l’insieme poco credibile: gli ultimi capitoli de “La casa del sonno” sono così pieni di coincidenze che viene da pensare sia stato questo il modo per strizzare l’occhio al lettore e dirgli non mi prendere troppo sul serio, mi ci sto divertendo.
Il che mi lascia il sapore di un chè di immorale, visto che la storia qualche emozione aveva suscitato.
La vita davanti a sé

Momo è un ragazzino arabo di dieci anni, ma forse undici, e strada facendo scoprirà che potrebbe averne anche quattordici.
Momo vive con Madame Rosa che, all’ultimo piano di un condominio senza ascensore, alleva una mezza dozzina di flgli di puttana.
Alla lettera: sono figli di prostitute che, per le leggi allora vigenti, hanno paura che i servizi sociali glieli tolgano e li diano in affido, e dunque li consegnano a Madame Rosa affinchè se ne prenda cura.
Per Madame Rosa è un lavoro: ogni madre le invia periodicamente soldi, ma Madame Rosa continua a tenere i bambini anche quando le madri scompaiono. Madame Rosa è una vecchia ebrea nera che ci sta poco con la testa, ogni tanto rivive epoche lontane ed è piena di acciacchi. Momo se ne prende cura alla fine più di quante cure abbia ricevuto.
Momo si è costruito un linguaggio tutto suo e una visione del mondo del tutto singolare.
Momo soffre per quanto Madame Rosa si deteriora: Madame Rosa gli ha detto che c’è una faccenda che si chiama Ordine dei medici che è fatto apposta per farle delle sevizie e impedirle di morire. Perciò Momo si arrabbia con il dottor Katz, talmente vecchio da dover essere portato in braccio per le scale per visitare Madame Rosa, quando gli dice che non la può abortire. Momo se la caverà a modo suo, e alla fine ci sarà anche chi si occuperà di lui.
PS: Romain Gary ha vinto il Goncourt con questo romanzo ma con uno pseudonimo: si è saputo solo qualche mese dopo che si è suicidato con un colpo di pistola. Era stato il marito di Jean Seberg, suicida un anno prima. Ha lasciato un biglietto: “Nessun rapporto con Jean Seberg, i patiti dei cuori infranti sono pregati di rivolgersi altrove“
ACCIAIO

Dopo poco i personaggi sono persone che conosci, e le cose che succedono, le vicende che li toccano sono cose che succedono a persone che conosci.