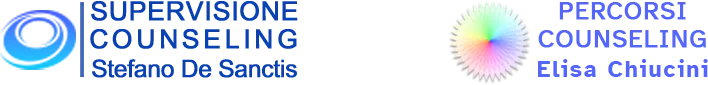Stoner
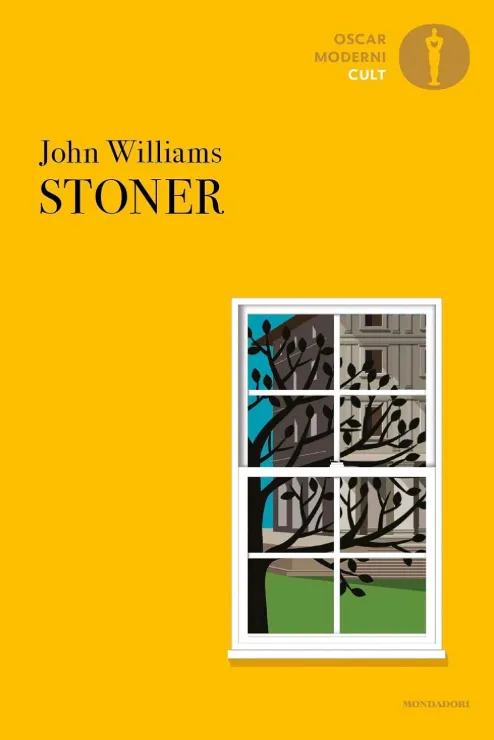
Lo avevo letto anni fa, me lo ha regalato un figlio a Natale, non ce lo avevo più da anni, chissà a chi prestato senza ritorno, è stata una bella occasione per rileggerlo.
Stoner è figlio di contadini che dovrebbe studiare agricoltura per poi aiutare i genitori che non se la passano bene ma si appassiona alla letteratura inglese del medioevo e passerà tutta la vità come insegnante nell’Università della Colombia.
La vita di Stoner si svolge fra le due guerre che a volte si affacciano con le loro tragedie ma sempre sullo sfondo. Si innamora, si sposa, ha una figlia, un nuovo amore difficile, contrasti in facoltà con colleghi e studenti.
È tutto qui, e non si stenta a credere che, come è documentato in appendice dallo scambio di corrispondenza con la sua agente letteraria, Stoner abbia avuto difficoltà a trovare un editore, tutti preoccupati della poca attrattiva che avrebbe potuto avere sui lettori un personaggio così scialbo e insignificante.
Eppure, questa sembra essere la sua forza, la mancanza di particolari qualità che, anche se viviamo in ambienti del tutto diversi da quello universitario, ce lo fanno sentire vicino, fino a farci appassionare a come andrà a finire la polemica con lo studente capzioso o lo scontro su una scemenza con il collega.
Le cose più drammatiche – emotivamente drammatiche – che succedono finiscono tutte con qualcosa come “alla fine è andata così” e tu che leggi ti senti spaesato e ti affezioni a quest’uomo ordinario, fondamentalmente buono, che non riesce nemmeno a esprimere fino in fondo il buono che lo muove.
Il breve brano che ho copiato trovo che lo descriva meglio di tante parole: è consapevole di che cosa (scrive “cosa”, non “chi”) è stato.
Nel tempo, è diventato quello che ogni editore vorrebbe per i suoi libri: un long-seller, cioè un romanzo che si vende sempre, con costanza; non un velocista, un passista implacabile.
Va letto assolutamente.
Avanti va il mondo

A pagina centotrenta delle trecentocinquanta di quest’opera ho lasciato perdere.
Una scrittura che si fa leggere – e ci mancherebbe, da un premio Nobel – ma una ripetitività e una ridondanza che per le prime cento pagine si esercitano sui pensieri profondi di chi scrive, senza fatti.
Da pagina cento circa arriva qualche personaggio.
Poi, sfogliando avanti, ci sono capitoli – direi racconti – in cui forse qualcosa succede.
L’ultimo capitolo si intitola:
“Il cigno di Instambul (79 paragrafi su pagine bianche)
In ricordo di Kostantinos Kavakis”.
Seguono venti pagine bianche, come promesso.
Nella pagina finale l’Autore ci fa sapere, con parole certo migliori della mia sintesi brutale, che il mondo non gli piace e che non vuole portarsi niente appresso.
Confesso il mio limite, ma la risorsa scarsa è il tempo.
La professione del padre

Un romanzo singolare, difficile da descrivere senza svelarne troppo.
L’inizio si può dire, perchè dalle prime pagine il quadro di un padre millantatore e violento, di una madre remissiva, di un figlioletto vittima, è chiaro.
Tutta la prima parte è densa di complotti, dell’amico americano Ted che dà istruzioni al padre a che a sua volta le trasmette al figlio o se ne fa scudo per le punizioni tremende che infligge al piccolo protagonista quando non esegue a puntino gli ordini o non è perfetto a scuola.
Pian piano il figlio diventerà parte attiva e proattiva dei deliri del padre. Diventerà grande, si costruirà una vita autonoma: un bel lavoro di restauratore, una moglie, un figlio.
Stavo per lasciarlo a metà, stanco della sequenza di “avventure” senza costrutto. Avrei fatto un grande errore, perchè la prima parte è stata necessaria a preparare una seconda parte bellissima, nella ripresa di contatto dopo anni del figlio con i genitori.
Di questa parte preferisco non dire niente, se qualcuno che leggerà qui vorrà leggere il romanzo, perchè l’ho letta non più stancamente come fin verso la metà ma appassionato e voglioso di arrivare alla fine dello svolgimento dei sentimenti che si sviluppano.
Senza le grandi contraddizioni che mi sarei potuto aspettare, e anzi con un tono piano, equilibrato, mai urlato. Commovente. Un sentimento che per qualche verso si avvicina a quello che ho avvertito nel vedere Joker, per la vicinanza, che in nessun modo copre le pessime azioni dei protagonisti, a stati di sofferenza estrema di alcune persone. DA LEGGERE
MI CHIAMO YURI

Conosco Patrizia Pieri come brava fotografa, il lavoro e la passione di una vita, immagino non sia stato facile passare da una modalità espressiva a un’altra senza portarsi dietro residui.
Invece, il romanzo è fatto di parole, come dev’essere, e “privo” di foto; a parte quella vera e propria della copertina che ferma un ambiente della storia particolarmente caro ad alcuni dei protagonisti.
La foto è stata presa a villa Sciarra, un bellissimo posto nel cuore di Monteverde, Roma, ora purtroppo molto trascurato, dove un gruppo di amici passava ore in cui nascevano amori, amicizie, qualche illegalità da adolescenti e qualche altra da giovani adulti che entrano in contatto con adulti feccia.
È la storia di un sentimento rimasto sospeso fra amicizia e amore, che dieci anni dopo un incidente stradale in cui Yuri muore – il protagonista appare solo nei racconti degli amici e della madre – è la spinta che induce gli amici più cari di Yuri a indagare su quell’incidente sul quale troppe ombre non sono state illuminate.
La storia prosegue scorrevole: la ricerca della verità – piena anche di avventure inattese, nello squallore di una mala romana tra cocaina fascisti e strozzini – va in parallelo con il crescere di un sentimento, osservato con grande delicatezza.
I piani temporali – oggi a trent’anni, ieri a venti, l’altro ieri fra tredici e quindici – si alternano fluidi e restituiscono lo spessore dei diversi personaggi e le rispettive evoluzioni, involuzioni.
Della madre di Yuri, Patricia, sappiamo che proviene da una famiglia ipocrita da cui è scappata e che ha incontrato un uomo – il padre di Yuri – rivelatosi un poco di buono.
Patricia resta sullo sfondo: non vuole credere alla casualità dell’incidente stradale – troppe incongruenze, troppi sospetti – ma il dolore incommensurabile della perdita di un figlio non le permette, sul momento, di cercare.
Cercheranno, per lei e con lei, Valentina e Andrea, gli amici più cari di Yuri, alla cui memoria questo romanzo, oltre a confermare l’amore di una madre, restituisce dignità e rispetto.
DA LEGGERE
Tutto chiede salvezza

Una settimana di TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) trascorsa da Daniele Mencarelli – il personaggio del romanzo ha lo stesso nome dello scrittore – in una stanza a sei letti del reparto di psichiatria di un ospedale, dopo l’ultima esplosione di rabbia che, oltre a distruzione di oggetti, ha prodotto ferite alle mani e lo svenimento del padre.
“Mi sembra che la vita mi pesi più degli altri”, dice Daniele, vent’anni, allo psichiatra. La sua ricchezza e la sua condanna è un’empatia priva di confini, che può diventare distruttiva.
Si alternano, nei colloqui, due psichiatri, uno assente l’altro più partecipe. Alla fine le parti quasi si invertiranno: il primo risolverà con inaspettata umanità una situazione molto difficile mentre l’altro si sarà rannicchiato in fuga da tutto.
Questa capacità di restituire, con poche pennellate chiare, la complessità e le contraddizioni di tutti i personaggi presenti a me pare una delle qualità migliori del libro.
Nelle sette giornate che Daniele trascorre lì, in un periodo di caldo afoso che rende a tutti difficile dormire e che fa svegliare inzuppati di sudore, Daniele conosce i compagni di stanza.
Due sono lì come lui in TSO, per poco tempo, finchè non passa il momentaccio; altri sono fissi, chi del tutto privo di sguardo e di mondo, chi alle prese con un passato irredimibile.
Poi ci sono gli infermieri. Ciascuno merita un ritratto non banale, non stereotipato; ognuno, anche chi appare di straforo o del tutto sullo sfondo, viene restituito con pochi tocchi che ne rendono la complessità.
Ci sono mezze pagine – la gravidanza “impossibile” fra due pazienti – che in poche righe alternano il sapore di pezzi di paradiso allo sprofondo nella realtà.
È un libro pieno di emozioni vere, che prendono chi legge proprio perchè le sente vere, mai strumentali alla storia da raccontare.
“La gratitudine che Mario sa restituirmi dovrebbero vederla almeno una volta nella vita tutti gli esseri umani esistenti. Come un’opera d’arte o un capolavoro della natura.”
Il padre e la madre di Daniele, i fratelli, li vediamo in controluce: una base sicura che gli permette di non perdersi del tutto. Forse pure che gli ha permesso di sperimentare lo sperimentabile nella certezza di ritrovarli: sempre, solidi.
Sul finale, un incidente: sono bastate meno di dieci righe a renderne la drammaticità.
A seguito dell’incidente, le reazioni emotive varie dei pazienti producono una scena in cui ciascuno rivela altre parti di sè. Bastano quattro pagine, senza alcun bisogno di calcare la mano su qualche effetto, a far succedere tutto e a restituire a ciascuno una collocazione.
La settimana di TSO finisce, Daniele torna a casa a piedi, immerso nella gioia dei colori intorno, dove tutto chiede salvezza.
Sono molto contento che sia entrato nella cinquina finalista dello Strega e che sia stato il più votato dai giovani. Della cinquina (sestina, quest’anno) ho letto Colibrì, mentre non conosco gli altri libri finalisti. Visto che il libro di Veronesi è stato il più votato dalla giuria che assegnerà il premio, non ho dubbi che Mencarelli meriti di vincerlo.
Un’ultima riflessione, simile a quella fatta dopo aver letto il suo primo romanzo: a un certo punto gli spunti tratti dalla vita di una persona si esauriscono, o si ripetono; auguro a Daniele Mencarelli di continuare a regalarci questa prosa anche con altri protagonisti.
A proposito di niente
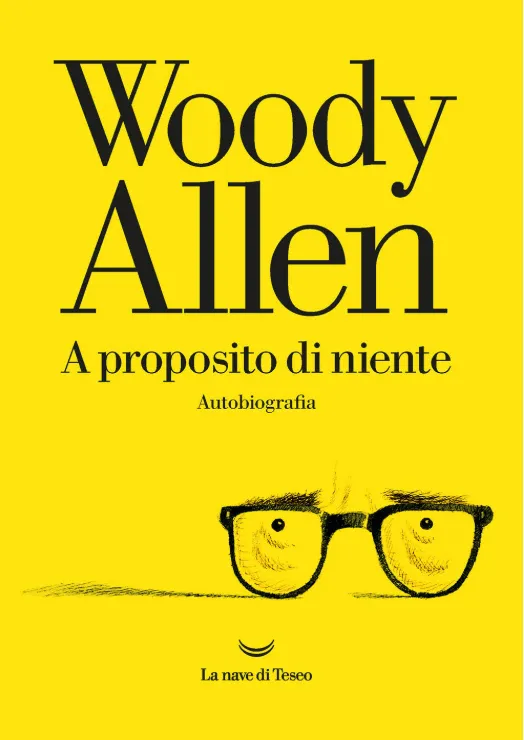
Quattrocento pagine di autobiografia che vanno dagli inizi – quindicenne – come scrittore di battute vendute a una società di promozione che li attribuiva a personaggi famosi della politica, dello sport, dello spettacolo fino agli ultimi film.
Mi ha fatto venire voglia di recuperare i pochi film che non ho visto e di rivedere i tanti che ho visto. Sono tutti, senza eccezione alcuna, film che è valsa la pena vedere e non ce n’è uno che non offra, oltre al divertimento, qualche spunto di riflessione esistenziale, ottima musica classica e citazioni colte anche se buttate là come se non lo fossero. Autobiografia più film restituiscono una persona che ha capito come funziona il mondo, che soffre delle ingiustizie ma non se ne meraviglia, così come non si meraviglia delle giravolte sentimentali di noi umani e che attribuisce al caso il principale peso di ciò che viviamo.
In mezzo, anche qualcosa sulla vita privata e sulle accuse che ha subito. Non c’è niente di pruriginoso, preferisco affidarmi alla riconstruzione che ne ha fatto “Il Post”. https://www.ilpost.it/…/woody-allen-accuse-violenze…/
Da parte mia trovo ignobile che l’editore Usa abbia rinunciato alla pubblicazione di questo libro così come il boicotaggio degli ultimi film e mi limito a due osservazioni: il matrimonio in corso dura da venticinque anni, alla coppia sono state date due bambine in adozione.
Nel libro sono citati credo tutti coloro che, nelle posizioni più diverse, lo hanno accompagnato nella lunga vita professionale e per ciascuno c’è almeno una parola di apprezzamento.
Tanti elogi anche per gli attori e le attrici: più d’una ha vinto Oscar con i suoi film e molte sono state candidate. I film corrispondono al personaggio che emerge dal libro: pieno di paure e ossessioni e tuttavia con una voglia di vivere smisurata – “io sono contrario alla morte” – che si realizza negli affetti quotidiani e nella produzione di sceneggiature – tutti i film sono “scritto e diretto da Woody Allen” – e regie dove è facile immaginare che rielabori fantasie e vissuti propri e di chi gli sta intorno.
Credo sia sincero quando, in conclusione, scrive “ho avuto milioni per fare film in totale libertà, e non ho mai girato un capolavoro”. Lo posso condividere: nessuno dei suoi film, da solo, è un capolavoro. Ma nessun regista al mondo ha girato più di cinquanta film – una media di uno all’anno – che vale la pena vedere, senza eccezioni.
Il finale di “Basta che funzioni”:
“Qualunque amore riusciate a dare e ad avere, qualunque felicità riusciate a rubacchiare o a procurare, qualunque temporanea elargizione di grazia: basta che funzioni. E non vi illudete.
Non dipende per niente dal vostro ingegno umano. Più di quanto non vogliate accettare, è la fortuna a governarvi: quante erano le probabilità che uno spermatozoo di vostro padre tra miliardi trovasse il singolo uovo che vi ha fatto? Non ci pensate, sennò vi viene un attacco di panico.“
Almeno una cosa (ultima pagina del libro) ce l’ho in comune con Woody Allen: “Il mio eroe preferito? Il cavaliere della valle solitaria”
Anatomia di un istante

Il ventitrè febbraio 1981 il colonnello Tejero irrompe nel parlamento spagnolo e interrompe la seduta di investitura di un nuovo governo.
Con un tricorno in testa spara da una pistola colpi in aria, seguiti da scariche di mitraglia, ancora in aria, da parte di altri della Guardia civil che partecipavano al golpe.
Intimano a tutti i presenti di nascondersi sotto ai banchi.
Tutti – deputati, inservienti, commessi – ubbidiscono.
Tutti eccetto tre: il presidente del governo dimissionario Adolfo Suarez, il generale Gutièrrez Mellado e il capo del partito comunista Santiago Carrillo.
Da questo fermo immagine parte un’analisi del golpe, un’analisi dei principali personaggi implicati – entreranno in scena il re con i suoi consiglieri, saranno stanati i golpisti di retrovia – e ci viene restituto un affresco della società spagnola dopo solo cinque anni dalla morte di Franco, con la nuova democrazia che stenta ad esprimersi, appesantita da un passaggio che ha evitato la resa dei conti e una probabile nuova sanguinosa guerra civile ma al prezzo di portarsi dietro tutto il fascistume dell’era di Franco.
Il libro è appassionante, ogni protagonista è reso a tutto tondo e in tutte le sfumature dei gesti e della storia personale e politica. Uno per tutti: Suarez è un galletto di provincia che, a carriera politica ormai finita, non esita ad affrontare a muso duro i golpisti. “…lo votavano perchè era come loro avrebbero voluto essere… la Spagna degli anni Settanta era più o meno così:
un Paese popolato da uomini volgari, ignoranti, cialtroni, giocatori d’azzardo, donnaioli e senza tanti scrupoli, provinciali con una morale da sopravvissuti allevati tra l’Azione cattolica e la Falange che avevano vissuto comodamente sotto al franchismo, collaborazionisti che non avrebbero mai ammesso la propria collaborazione ma che in segreto se ne vergognavano sempre di più e confidavano in Suarez perchè sapevano che … sarebbe sempre stato uno di loro.“
È anche una specie di giallo con la ricerca, nei fatti e nelle dichiarazioni, delle vere intenzioni di ciascuno, prima e durante il golpe; perchè il golpe fallì in un giorno e mezzo, ma in quelle ore la regione militare di Valencia si sollevò, restò aperta fino all’ultimo l’opzione golpe duro / golpe morbido, pochi, pochissimi, si schierarono subito apertamente da una parte o dall’altra mentre i più cercarono di mantenere l’ambiguità sufficiente a schierarsi dalla parte giusta – quella vincente – una volta conclusa la vicenda.
Una delle pagine più belle descrive i saluti affettuosi, all’uscita dal parlamento-prigione, di Suarez, Mellado, Carrilo verso il generale Armada, che sarà poi condannato per il golpe ma che in quel momento credono sia stato il loro liberatore, mentre la sua presenza è la garanzia che Tejero ha chiesto per infine arrendersi.
Non c’è una donna, non c’è una storia d’amore, tuttavia un gran libro. Cercherò anche “Soldati di Salamina”.
Ogni coincidenza ha un’anima

Il protagonista si è inventato un lavoro che a quanto pare gli funziona: ascolta i bisogni di persone che gli si rivolgono e prescrive loro libri.
Arriva la figlia di un grande intellettuale, malato ora di alzheimer, gli chiede di capire, in base a pochissimi indizi lasciati dal padre, di quale libro possa trattarsi.
L’impresa sembra impossibile, ma il nostro è sagace e fortunato.
Se troverà il libro ed eventualmente come utilizzerà il ritrovamento o il non ritrovamento non lo scrivo, perchè è questo il filo, tenue ma bel sviluppato, delle duecento cinquanta pagine – quelle piccole formato Sellerio – del libro.
I personaggi che si alternano nello studio del biblioterapeuta servono a intervallare la storia principale che altrimenti sarebbe poca cosa; sono ben descritti, vivaci, ma del tutto inessenziali alla storia e un po’ fastidiosamente orientati a farci sapere come la pensa l’autore del mondo.
Anche i tanti libri citati – ce ne viene offerto l’elenco in appendice – mi hanno dato l’impressione che l’autore si sia messo davanti alla sua biblioteca e abbia scelto ciò di cui gli piaceva scrivere.
La storia è comunque gradevole e molto ben scritta, scivola via leggera con un finale grazioso e inesorabilmente political correct.
Il sale della terra

Un romanzo appassionante, di quelli che il giorno dopo vuoi continuare per sapere che cosa succederà ancora e come andrà a finire. Una donna di Acapulco, appassionata libraia, innamorata del marito, con una bella famiglia, coltiva un’amicizia singolare con un uomo colto che sostiene di rivelare solo a lei il suo essere più profondo. L’amicizia si rivelerà più pericolosa di quanto potesse sembrare, e la donna sarà costretta a scappare per tutto il Messico, col figlio appena adolescente, per cercare di raggiungere gli USA.
In Usa l’autrice è stata accusata di avere in qualche modo “usurpato” la titolarità dell’identità della donna messicana in fuga. La questione è forse un po’ più controversa: c’è stato uno scatenamento contro Oprah Winfrey – a un libro presentato nella sua trasmissione il successo di vendite è assicurato – che aveva magnificato il romanzo, della serie “come ti permetti di esaltare questo libro scritto da una borghesuccia americana la quale che ne può sapere del dramma dei profughi centroamericani, quando ci stanno tanti altri bellissimi romanzi scritti da messicani veri?”
Personalmente, trovo queste polemiche stucchevoli: chi scrive mette se stesso in quello che scrive, un romanzo è un romanzo, non un trattato di sociologia. Ciò detto, la parte avvincente del libro è la fuga per tutto il Messico, gli innumerevoli ostacoli da superare, i tradimenti, le persone di buon cuore, i viaggi sul tetto dei treni, i cacciatori di migranti, in un insieme davvero coinvolgente.
Non ho le conoscenze dirette per sapere se quella descritta si avvicina alla realtà, ma resta il fatto che ho respirato la paura, la caparbietà, il coraggio, la sofferenza, la solidarietà, la spietatezza dei tanti protagonisti. Sono questi i risultati da chiedere a qualsiasi scrittore – scrittrice, il resto mi sembrano polemiche sterili, come quelle sui personaggi dello spettacolo che non vado più a vedere i suoi film perchè è cattivo/a. Il nucleo per cui vale la pena leggere questo libro è il viaggio, con la tanta umanità che lo percorre. Inizio e fine li ho trovati non tanto credibili, ma sono serviti da complemento all’insieme, e alla fine importano poco.
Karoo

Karoo è uno sceneggiatore di grande successo: i suoi interventi sono considerati miracolosi nel riuscire a rimettere in piedi un film zoppicante, nel far diventare un grande successo quella che poteva essere una storiella, nel rendere almeno accettabile qualcosa di penoso.
Per qualche mistero della chimica e della fisica, a un certo punto della sua vita Karoo può bere senza limite e senza ubriacarsi ma, siccome tutti lo conoscono come “uno che beve”, finge ogni volta di essere ubriaco per compiacere gli interlocutori e non indagare oltre circa il suo corpo.
La caratteristica principale di Karoo è la mancanza di un bypass fra se stesso e la realtà.
Questo può essere osservato attraverso due, complementari, modalità comportamentali: in certe circostanze sa esattamente che cosa davvero vuole ma agisce altrimenti; in altre, sa esattamente che cosa l’altro si aspetta da lui, glielo promette, glielo giura, e fa regolarmente altro.
Karoo, in effetti, riscrive continuamente la sceneggiatura della sua vita.
Con la quasi ex moglie, che lo conosce a fondo e lo svela senza pietà – il capitoletto che parte da pag. 282 è un capolavoro a se – ha un divorzio in corso senza che si facciano veri passi avanti.
Al figlio adottivo poco più che ventenne, che si ostina a voler credere alle promesse del padre, continua a rifilare buche clamorose.
Va, solo perchè vuole pubblicamente sbranarlo per le sue note nefandezze, all’appuntamento con il feroce produttore di Hollywood, e si ritrova sedotto e coinvolto nello scempio dell’ultimo capolavoro, di cui riconosce la grandezza artistica, del famoso regista, morente.
Nel flm del famoso regista gli sembra di individuare qualcosa che lo induce a mettersi alla ricerca della madre naturale del figlio. Le vicende che seguiranno, dove la mancanza di bypass fra sè e la realtà produrrà situazioni fra il tragico, il divertente, lo squallido, l’inverosimile, sono il clou del romanzo.
Gli avvenimenti saranno tali che un famoso giornalista decide di scriverci un articolo, va alla ricerca dei protagonisti, di chi li ha conosciuti e li conosce, e il risultato è tale che “con un minimo di allenamento ce l’avrebbe fatta a diventare anche in privato, ai suoi stessi occhi, la persona che era ritenuta in pubblico.“
Il finale è degno del personaggio, che ha tanti di quei lati pessimi che non possiamo fare a meno di provarne compassione, mista a un pizzico di simpatia per la sua vitalià inesauribile.
Vita e morte di un ingegnere

Scritto subito dopo “La scuola cattolica“, e da me letto subito dopo, è come se fosse una continuazione. Come se dopo aver esplorato un quartiere borghese, una scuola privata, un delitto che in quell’humus ha preso forma, Albinati abbia deciso di andare in profondità nella vita del padre.
L’autore scrive ancora in prima persona, è lui presente, non si tratta di un romanzo, si tratta della descrizione del padre, del quasi non rapporto con quest’uomo dedito al lavoro, del quale la moglie spera che l’avvicinarsi della morte “porti a galla i tesori sepolti… senza capire che il tesoro era appunto quell’acqua limpida… in fondo alla cui singolare trasparenza non c’era niente che non fosse da sempre visibile a occhio nudo”.
Mi sono chiesto se mi piacerebbe risultare così a un figlio e no, non mi piacerebbe: quella “singolare trasparenza”, che pure fa pensare a una persona “pulita”, senza contraddizioni, la sentirei addosso come un limite.
Il libro – 159 pagine – è diviso in due parti, quasi paritarie, ma anche se della malattia e della morte si tratta nella seconda parte, malattia e morte sono presenti in tutto il racconto.
A me è rimasta impressa con forza la descrizione puntigliosa, dotata di una pietas tenuta a bada da un intelletto poco incline alle sbavature emotive e che tuttavia arriva al lettore, che si chiede – io mi chiedevo – ma ne avete tutte le possibilità, perchè non lo fate morire in pace?
La risposta ci viene data, anche se la domanda nel testo non è posta, e sono quei piccoli gesti che possono essere scambiati, senza poterne essere certi, per attaccamento alla vita, e ai quali non può essere negato valore.
Accompagnamo così l’ingegnere nelle riprese, nelle ricadute, in alcuni trattamenti quasi sicuramente inutili, talvolta dolorosi oltre che inutili, funzionali probabilmente solo al profitto della clinica, fino alla morte nel letto di casa, con i cari vicini ma senza che riesca a godere della loro presenza mentre qualcuno, di sicuro l’autore, cerca, e forse riesce, a beneficiare fino all’ultimo respiro del padre, anche se non sembra riuscire a riconoscerne il sapore.
Difficilmente saremo sollevati dal doppio arcobaleno che si staglia sulla Flaminia mentre la famiglia torna a casa dopo la cremazione.
LACCI
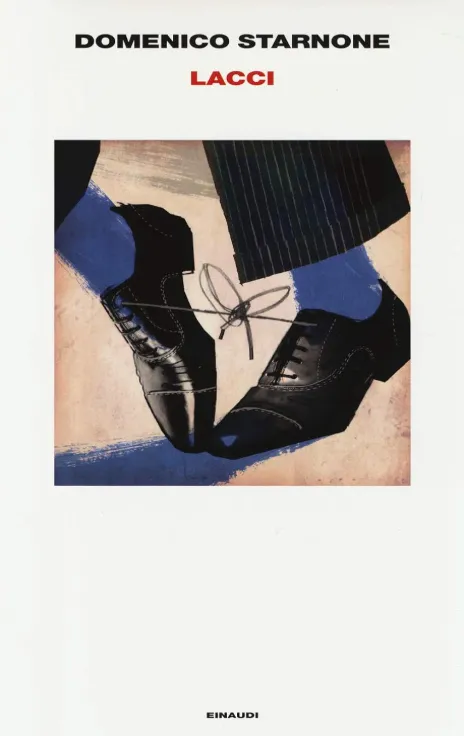
Lo capisco, definirlo “disperato” può non attrarre, e tuttavia vale la pena leggere questo ultimo romanzo di Domenico Starnone.
Ne lessi, e rilessi – uno dei libri più divertenti che io abbia incontrato – “La scuola”, agli esordi, poi uno o forse due altri romanzi che non mi hanno lasciato traccia; questo “Lacci”, invece, mi ha colpito per il pessimismo cosmico che trasmette, vestito di uno stile sempre accattivante e piacevole.
Una coppia va in crisi: lui si è innamorato di una ragazza più giovane e vuole viversi questa esperienza. Niente di più banale, eppure i bei romanzi non sono dati dal raccontare storie nuove, ma dal come vengono raccontate. E Starnone sa raccontare, sa tenere l’attenzione viva, la curiosità sveglia.
Ci saranno evoluzioni, naturalmente, che qui non racconto.
Ci sono, oltre a marito, moglie, amante di lui, due figli, che da bambini patiscono l’assenza del padre e da adulti si confrontano sulle identità dei genitori, e infine un gatto, con un suo ruolo nella narrazione.
Benchè il finale sembri aspirare a trasmettere un senso di vitalità e spensieratezza, non si salva nessuno. L’impressione è che l’autore non li sopporti proprio, i suoi personaggi, come se il suo approccio allo stare al mondo avesse esaurito tutte le energie a cercare di capirlo e ci avesse rinunciato, senza essersi arreso al fatto che, “capire”, non si può.
“Se tu te lo sei scordato, egregio signore, te lo ricordo io: sono tua moglie“.
Questo è l’incipit “Ti mostri affettuoso e intantio sfoghi i cattivi sentimenti per vie traverse“, dice la moglie del marito.
“Mio fratello è un uomo finto… sa mimare bene tutti i sentimenti senza mai provarne nessuno”, dice la sorella del fratello, da adulti.
I VAGABONDI
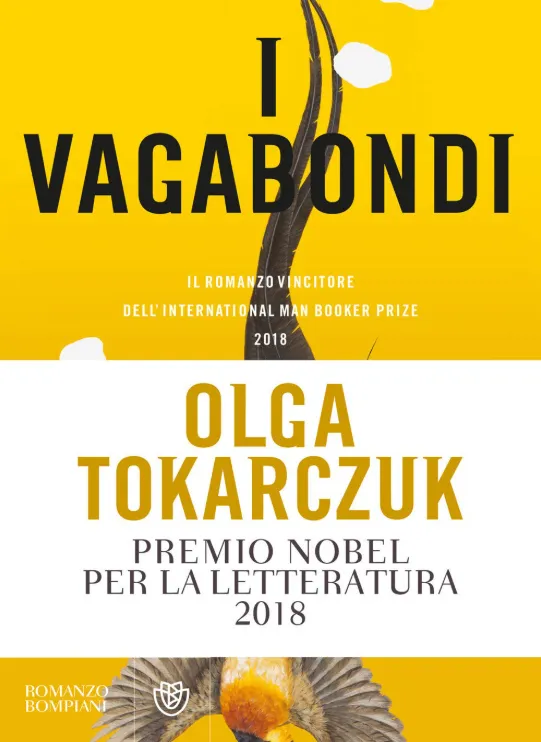
Non è un romanzo, ma poco importa. D’altra parte nemmeno lo si sarebbe potuto definire una raccolta di racconti, anche se ci sono dentro almeno due, tre racconti molto belli.
Una serie di impressioni di viaggio fra aeroporti, treni, incontri occasionali, metropolitane.
Eppure l’autrice riesce, e senza fornire appigli di collegamento, a mantenere amalgamate le storie che racconta. Oltre al tema del viaggio, la conservazione dei corpi dopo la morte: il cuore di Chopin trasportato dai suoi amici; lo schiavo nero diventato il confidente saggio dell’imperatore e, dopo morto, le struggenti lettere della figlia all’imperatore, affinchè cessi quella barbarie di esporlo impagliato come un fenomeno; la donna che vaga per la metropolitana e incontra una barbona che ha una sua storia; moglie e figlio che scompaiono per due giorni durante una vacanza e, anni dopo, il marito/padre che ancora chiede alla moglie come sono andate le cose.
Sarei molto curioso di sapere come ha deciso l’ordine in cui ha disposto i capitoletti.
Per esempio, il racconto più lungo, di moglie e figlio che scompaiono, è esposto in tre parti diverse, riconoscibili dallo stesso titolo: prima dieci pagine e poi altre sedici con in mezzo solo un paio di capitoletti di mezza pagina, infine ripreso duecentocinquanta pagine dopo. Perchè duecentocinquanta e non cinquanta o cento o duecento? E tutti gli altri “titoli”, piuttosto brevi, ha un senso che siano collocati dove stanno o è puramente casuale?
Già porsi queste domande esclude che di romanzo possa trattarsi e che abba una struttura. Eppure, chiamatelo come vi pare ma leggetelo, perchè ne vale la pena.
L’autrice ha originariamente studiato psicologia e qui si è inventata una “psicologia del viaggio” che fa capolino qui e là fino alla fase chiave: “qualunque sia la destinazione, si viaggia sempre in quella direzione. Non importa dove sono, non fa differenza. Io ci sono.”
Quello che non ti dicono
Mario Calabresi è stato direttore de La Stampa e di Repubblica, da dove è stato mandato via perchè “troppo equilibrato” (ovviamente non fu questa la motivazione ufficiale).
Un passo indietro: quando, per stornare le indagini sulla bomba di piazza Fontana dai fascisti – poi riconosciuti responsabili – lo stato cercò di indirizzarle verso gli anarchici, il commissario Calabresi era colui che aveva in custodia l’incolpevole anarchico Pinelli, che morì dopo essere volato giù da una finestra della questura di Milano. Perciò il commissario Calabresi diventò, in quella stagione dolorosa, uno dei “cattivi” designati, e fu assassinato a revolverate.
Mario Calabresi è il figlio del commissario Calabresi e ha raccontato, in “Spingendo la notte più in là”, l’evoluzione della sua famiglia dopo l’assassinio del padre – 1972 – con un equilibrio più che raro.
In questo nuovo libro scrive che, dopo il precedente, aveva giurato di non tornare più su quel periodo, ma un frate dall’Algeria gli parla di una sua quasi coetanea, che ha vissuto una vicenda dolorosa rimasta dimenticata.
Quasi coetanea perchè nata dopo la morte del padre, nel 1975, a sua volta morto senza sapere che gli sarebbe nata una figlia.
Marta è la figlia di Carlo Saronio, proveniente da una delle più influenti famiglie di Milano, ricca di un impero chimico.Carlo rifiutava i suoi privilegi e oscillava fra volontariato cattolico e istanze gruppettare rivoluzionarie, tanto da mettere a disposizione alcune residenze familiari per attività criminali/terroristiche.
Quando, anche perchè innamorato della madre di Marta, se ne stava probabilmente staccando, fu rapito, forse consenziente, forse no, dai suoi stessi compagni, che ne chiesero il riscatto.
I criminali comuni ai quali fu appaltato il rapimento furono talmente stupidi – sembra di stare in un film dei Coen – da sbagliare la dose di anestetico, tanto che Carlo morì subito.
Riuscirono tuttavia a far credere che fosse vivo e a ottenere un riscatto.
La storia è quella del dramma di una famiglia, in un periodo in cui i rapimenti erano il mezzo preferito della malavita – otto in contemporanea, in quei mesi – e del dramma di una giovanissima che si ritrova da pochissimo incinta e con la famiglia del compagno, con l’unica eccezione della madre di Carlo, che la vede come un’approfittatrice. Solo anni dopo, grazie a un pentito, il corpo di Carlo sarà ritrovato. Il frate dall’Algeria è un cugino di Carlo, schifato dal comportamento della propria famiglia verso la madre di Marta.
Questa la storia. Tutto sommato una storia “semplice”, che Mario Calabresi sa restituire come un appassionante giallo attuale, ricostruendo il clima, gli odori, i sapori di un periodo della nostra storia difficile da immaginare per chi non l’abbia vissuto.La scrittura è piana e onesta, a testimonianza di un equilibrio raro.
L’infedele
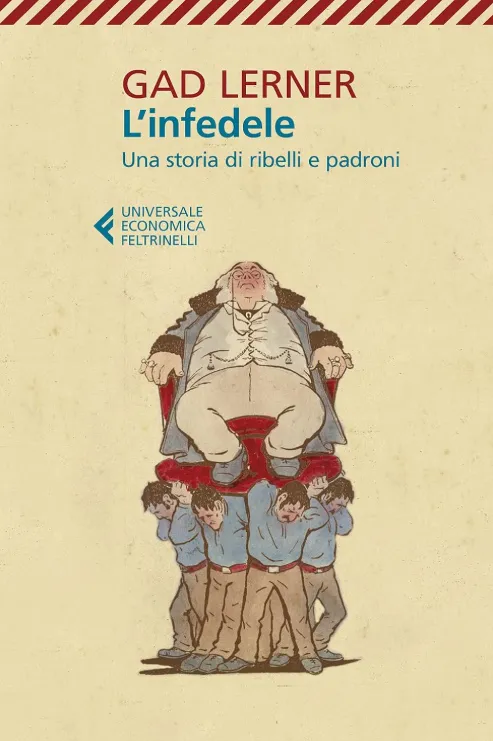
L’ho divorato in due giorni.
Un intellettuale onesto che è arrivato, partito da Lotta continua, al POTERE (la direzione del TG1), attraverso le collaborazioni più diverse, più prestigiose, più innovative, e che ora sta partecipando – quale uno degli intervistatori, non da organizzatore che guarda le cose dall’alto – al progetto di raccogliere le testimonianze video di tutti coloro che sono ancora vivi e che hanno partecipato, nei modi più diversi, alla lotta di liberazione dal nazifascismo.
Offre il petto al plotone di esecuzione dei filistei quando si riconosce come un possibile prototipo del radical chic, e rivendica di avere avuto, da un certo punto in poi, un’esistenza agiata, e di avere amici ricchi e potenti con i quali a volte condivide, da invitato, vacanze lussuose.
Si rende conto, quando guarda al distacco della sinistra dai lavoratori delle fabbrche, dagli operai, che non è da una figura come la sua che la sinistra potrà rinascere, e tuttavia non rinuncia a volersi rivoluzionario, contro lo stato di cose esistente e a favore dei diseredati.
Propone un collegamento con quella parte dell’ebraismo che si vuole messianica, ricorda che Engels era figlio di un grande industriale tessile e che questo non gli impedì di scrivere testimonianze dal vivo della condizione degli operai di Manchester, all’inizio della rivoluzione industriale.
Interessanti e godibili una serie di schizzi dei personaggi della nostra storia recente, della politica, della cultura, dell’impresa, del giornalismo, ciascuno collocato nel contesto storico di riferimento, senza rinunciare a note critiche anche profonde ma mai con astio o acidità personale.
Gad Lerner è uno che ha raccontato la lega dell’inizio delle ampolle alle sorgenti del dio Po’ ed è uno che oggi va nella piazza di Cerignola, dove le case e le strade sono piene delle immagini, come di un santo laico, del fondatore della CGIL Di Vittorio, a parlare con i braccianti, anche gli anziani che con Di Vittorio hanno lottato, e incontra il disincanto delle condizioni peggiorate, dello straniero visto come concorrente al ribasso e, sopratutto, della mancanza di prospettiva, che ha fatto di un paese del sud, glorioso di lotte contadine, un avamposto della lega.
È più che esplicito, a volte quasi compiaciuto, durante tutto il libro: me le dico da solo le contraddizioni che vivo, prima che me le tiriate addosso.
A suo modo è un libro di storia italiana dagli anni sessanta a oggi. Ripeto: l’ho letto di un fiato, leggetelo, ne vale la pena.
Diceria dell’untore
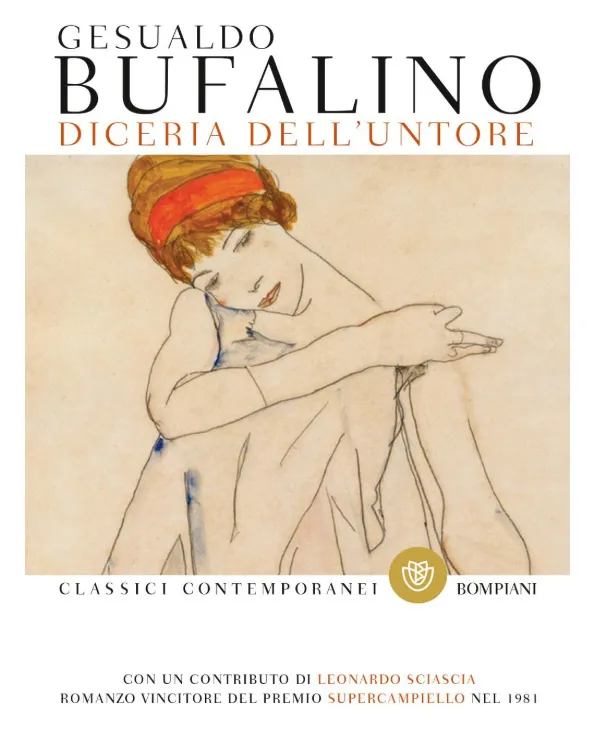
Per leggere un libro di Bufalino bisogna innamorarsi della sua scrittura. Me ne sono innamorato con “Le menzogne della notte”,
ed ecco qui il più famoso “Diceria dell’untore”.
È una storia, se vogliamo banale, di un amore e di competizione per una donna all’interno di un sanatorio per malati di tubercolosi. Qualcuno morirà, qualcuno è già morto e non lo sa, o lo sa, qualcuno si salverà.
Qualche assaggio, perchè non riuscirei a renderne la grandezza.
“Si scambiavano frantumi di suono, una poltiglia di sillabe balbe rimasticate in eterno da mascelle senili”
“Il sole sbocca dai tetti, grondante tuorlo, orrido mestruo del cielo. Il soffio che ne nasce non fa nemmeno sudare, ma stringe dentro un pugno il cuore, scaglia le rondini a rompersi contro la sciara, dovunque fa mulinello, e le illude, un inesistente palpito d’acqua.”
“Avevo più letto libri che vissuto giorni, nel mio così fuggitivo, così inefficace passaggio lungo le stradde degli uomini.”
“Voglio cercarmi un bambino per la strada… Gli darò uno schiaffo, gli dirò un’oscenità, una bestemmia di quelle che non si scordano. Voglio durare cinquant’anni ancora dentro di lui.”
“… nei miliardi di secoli passati e futuri io non so trovare evento più importante della mia morte.
E tutte le carneficine e derive di continenti e scoppi di stelle sono soltanto canzonetta e commedia al confronto di questo minuscolo e irripetibile cataclisma, la morte di Marta. Cosa non farei per ritardarlo di un attimo. La puttana, la spia, l’aguzzina. E chissà che non l’abbia già fatto.”
In generale, non amo questo tipo di scrittura ridondante, non vorrei mai scrivere così.
Ma dalla scittura di Bufalino sono affascinato, come da un gorgo che ti attira e non ti lascia.
Il libro varrebbe la pena averlo, per chiunque scriva, anche solo per l’appendice finale, aggiunta in questa edizione: c’è l’indice dei “Temi”, fatto dall’autore, c’è la spiegazione delle scelte di scrittura, ci sono note quasi per ogni pagina. Non per caso lo cominciò a scrivere negli anni cinquanta e fu pubblicato nel 1981. Per me, un grande della nostra letteratura.
L’angoscia del re Salomone

Questo romanzo, come il precedente “La vita davanti a sè“, uscì firmato da Emile Ajar. Con questo stratagemma Roman Gary vinse per due volte – il regolamento lo avrebbe vietato – il premio Goncourt. Si dev’essere divertito un sacco, visto che il segreto è riuscito a portarselo nella tomba.
Come nel precedente, il protagonista è un outsider, che parla una lingua tutta sua con la quale pronuncia inconsuete verità:
Jeannot è stato ingaggiato da Salomon, un vecchio di ottantacinque anni, ricco di trascorsi industriali, come tutto fare; Salomon sostiene un centro – una sorta di telefono amico – e qualche volta è lui stesso la notte, a rispondere alle telefonate dei disperati, perchè, dice Jeannot, “la notte si sente maggiormente angosciato e appunto quando è più solo ha bisogno di qualcuno che abbia bisogno di lui.”
Sembra aver imparato la lezione che Salomon gli ha dato quando si sono conosciuti: “… che si sono sempre sentiti sfigati e respinti e che si rifanno diventando psichiatri e si occupano dei giovani drogati e dei poveri disgraziati e si sentono importanti e sono molto ricercati e circondati da ammirazione…“
La vicenda centrale è tuttavia una triangolazione che si snoda, con la mediazione del centro di assistenza telefonica, fra Salomon, Jeannot e Cora, una anziana cantante che ha avuto un breve momento di gloria negli anni della guerra.
Scopriremo strada facendo perchè Cora non ha potuto proseguire una carriera che sarebbe potuta essere importante, scopriremo quale relazione c’è stata fra Salomon e Cora, quali segreti nasconde, vedremo quali saranno i modi, in parte casuali, in parte orientati, con i quali Jeannot e Cora si avvicineranno. Un libro delizioso.
La città dei vivi

Una brutta storia del 2016, quella raccontata ne La città dei vivi da Nicola Lagioia: due ragazzi, Manuel e Marco, per due giorni torturano e infine uccidono, in un appartamento di Roma, Luca, che conoscevano appena.
Un delitto insensato, senza movente, fa particolarmente orrore, appare più disumano che altri delitti.
Non c’è nessuna indulgenza sui particolari di quei due giorni, c’è uno scavare, con attenzione e comunque rispetto, nelle vite dei due carnefici e della vittima, c’è il tentativo di entrare in contatto con i loro mondi.
C’è il tentativo di entrare in contatto con l’umanità, comunque, della ferocia e della noia, di non scansare i mostri perché altro da noi.
Tentativo, credo, riuscito. L’autore ha sentito la necessità di esserci, e per questo di scrivere in prima persona. Avrebbe potuto fare altre scelte, ma fin dall’inizio ci fa sapere di essere stato toccato personalmente dalla vicenda, per fatti lontani anche se, nel loro contenuto, non paragonabili. Ma sotto ci sono, anche se non del tutto esplicitate, le domande “se si fossero presentate circostanze particolari, potrei esserne stato protagonista anche io, allora? Potrei domani?”.
Domande rivolta a sé stesso, e questo gli dà legittimità e forza per proporle a chiunque legga.
E io credo che ciascuno possa ritrovare, nella memoria, situazioni vissute. Questa è la ragion d’essere, credo, di un libro così difficile. Dove parlano amici, parenti, vengono ricostruite circostanze, dove attraverso i racconti di chi li ha conosciuti, di chi li ha cresciuti, i tre protagonisti acquistano forma e dimensione.
È un libro i cui protagonisti sono uomini. Le donne presenti sono figure di contorno rispetto alla narrazione. D’altra parte, non credo esistano esempi di donne che seviziano qualcuno fino alla morte. Dunque, è il maschile che deve interrogarsi. Così come ne “La scuola cattolica” che, scavando nel delitto del Circeo, decostruisce spietatamente, e ne mostra le viscere aperte, un sistema educativo, un quartiere, il genere maschile.
Roma non ne esce bene, ma nemmeno la Puglia ne usciva bene, anzi, ne “La Ferocia”, e la letteratura o fa venire dubbi oppure a che serve scrivere?
A trovarci un difetto, l’inutile storia parallela del turista olandese, mero espediente per aprire e chiudere, secondo me del tutto superfluo. Continuo ad apprezzare la scrittura di Nicola Lagioia e il suo modo di intendere l’impegno civile anche nella scrittura.
Il clan dei Mahé

Una gran fatica, arrivare alla fine.
Sconcertante.
A voler trovare un tema, un senso: un medico trascinato da una passione che nemmeno è una passione per una adolescente appena intravista con la quale nemmeno parlerà mai.
Una vita monotona che trova un’occasione per rigirarsi… sì, le atmosfere sonnacchiose di una provincia francese umida, ma che altro?
Mi ha veramente detto poco, ma forse sono io a non aver trovato.
DUE VITE

Premio Strega 2021, centoventi pagine che scorrono, letto in un pomeriggio.
Non conoscevo, prima di leggere questo libro, nè Rocco Carbone nè Pia Pera….
Di un amico – scrittore – e di un amica – traduttrice – dell’autore, morti prematuramente.
Purtroppo, la letteratura sopravanza la vita.
La direzione del pensiero – Helgoland
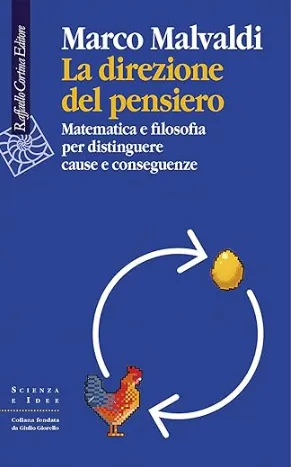
Marco Mavaldi è più noto come scrittore della serie di gialli Sellerio “I delitti del Bar Lume” , ma è un chimico, che ha messo la gradevolezza della sua scrittura al servizio di qualcosa di cui oggi mi pare ci sia tanto bisogno: distinguere cause da conseguenze.
Carlo Rovelli è un fisico teorico importante, già autore, fra l’altro, de “L’ordine del tempo”. Helgoland è l’isola sperduta nel Mare del nord dove Heisenberg, a ventitrè anni, avviò la teoria quantistica.
È stato casuale che mi sia trovato a leggerli uno dietro l’altro, e in qualche momento alternandoli. Non mi azzardo a ripercorrerne gli argomenti; in questi casi io funziono così: leggo, mi appassiono, qualcosa capisco, molto intuisco, tanto so che è fuori dalla mia portata, eppure provo un’attrazione fortissima per l’inarrivabile.
Mavaldi parte da Hume: “la causa è qualcosa che, se rimossa, fa sì che l’esito non avvenga”. Poi allarga l’orizzonte a “che cosa accadrebbe se?” e a “che cosa sarebbe (o non sarebbe) accaduto se invece?” come metodi per individuare, per approssimazioni successive, quali dati sono più significativi per assumere una decisione. Molto interessante il risultato del confronto fra Cina e Italia sulle diverse risposte al virus.
Alcuni esempi sul calcolo delle probabilità pure sono gustosi, come quello del giudice che assolve colui che è stato trovato con 50 bustine di polvere bianca e le uniche tre esaminate contenevano tutte eroina. Lo assolve perchè dall’arresto al processo le 50 bustine sono state distrutte, e l’avvocato convince il giudice che, senza la prova che tutte e 50 contenessero eroina, le sole tre potevano essere per solo uso personale. In un caso analogo, un altro giudice condannò, quando calcolò che la probabilità che su 50 bustine fossero state casualmente prese le sole tre contenenti eroina era 1/26.000. Spunti finali su possibili teorie della “coscienza di se”.
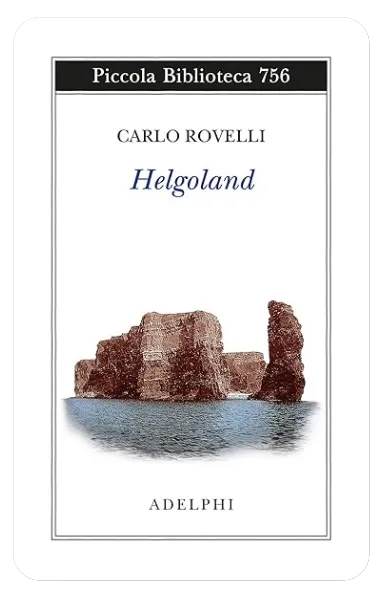
Rovelli ci dice che la fisica, non descrive “come la Natura è”, ma solo “quanto possiamo dire della Natura”.
Qualcosa che sembra ormai provato è che nulla esiste “di per sè”, ma solo “in relazione a”. Ciò, non soltanto nel mondo delle relazioni umane, dove il concetto è da tempo acquisito, ma anche nel mondo della materia, dove le cose fisiche hanno proprietà solo quando interagiscono: l’interazione è parte inseparabile dai fenomeni.
Il mondo pullula di correlazioni, la maggior parte delle quali non significa letteralmente niente: succede qualcsa di straordinario quando identifichiamo quelle significative, quando si combinano informazione ed evoluzione. La sfida sta ancora nell’approfondire come significato, intenzionalità, sensazioni soggettive si combinano e, per tornare al primo libro, dove sta la causa e dove l’effetto.
Questa è l’acqua

Mi rendo conto, a distanza di una decina di giorni da quando ho finito di leggerli, che di nessuno ricordo la trama.
Di tutti ricordo i personaggi, le atmosfere, le situazioni.
I racconti di David Foster Wallace una trama ce l’hanno: è che a me è rimasto impresso altro: una scrittura movimentata, allusiva e descrittiva insieme. Con tutta la gamma dall’ironia al sarcasmo.
Ecco qua: “Onassis, sul suo yacht …. rimugina davanti a un succo di sedano nell’angolo bar, seduto su uno sgabello di teak. Il sedile dello sgabello e la superficie del bancone sono rivestiti di raffinatissima pelle grigiazzurra ricavata dallo scroto di capodoglio sotto la supervisione personale della signora O. Onassis gira i cubetti di ghiaccio con il grosso dito.”
Da rileggere, prima o poi.
APPREZZABILE
ANARCHIA
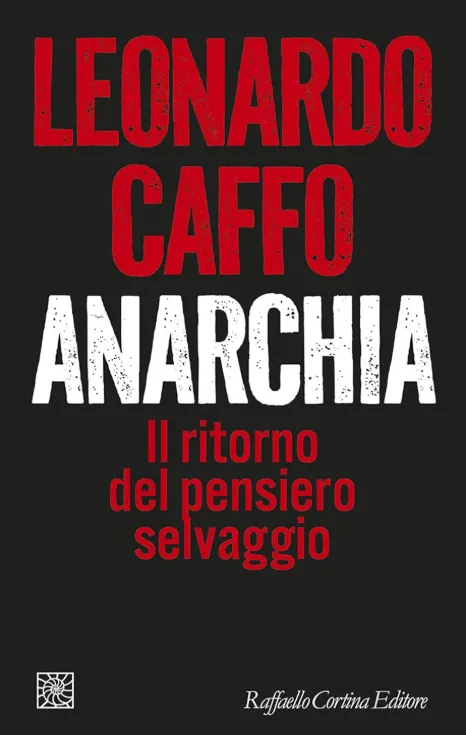
Fino a pagina cento (la metà) ho letto e pure sottolineato (lo faccio sempre), poi ho sfogliato fino alla fine, perchè se nella prima metà di un libro che si propone filosofico non ho trovato niente di originale me lo faccio bastare.
Il tutto si riduce alla considerazione – sostanzialmente antropologica, più che filosofica – che sono esistite ed esistono società basate sull’eguaglianza dei loro membri che campano felici e contenti.
Caffo le vuole definire “anarchiche”, e passiamogliela, ma non c’è una, dico una, considerazione sulla differenza fra queste società composte di pochi individui che vivono in spazi quasi privi di contatti con il “fuori” e la dimensione, e quindi la complessità, delle società come le abbiamo costruite nei secoli.
Alla fine l’anarchismo mi pare preso a pretesto per raggruppare sotto a un unico cappello tutto ciò che si oppone allo stato delle cose in cui il capitalismo ha trionfato, con le conseguenze che possiamo osservare. A me sono sembrate semplificazioni poco all’altezza di quello che si pretende pensiero filosofico.
Traspare, sì, una grande passione civile – Caffo da anni, per un mese, fa un seminario residenziale a Lampedusa dove prova a far sperimentare, a se stesso e agli studenti, almeno qualcosa della vita dei migranti che lì sbarcano e che scompaiono alla vista – e un impegno sincero a cercare vie di uscita, ma “chi prenderebbe sul serio un processo per aver rubato un motorino o picchiato la sorella mentre nezzo mondo crolla sotto l’effetto dei gas serra?” mi suona infantile e inquietante, non meno dell’inevitabile richiamo al potere insurrezionale dello sciamanesimo e compagnia bella.
La conclusione, dalla nicchia di pensiero filosofico che pare essersi ritagliata, detta “Postumanesimo contemporaneo”, è che il collasso è inevitabile e che è meglio prepararsi.
Mi era piaciuto di più come lo aveva detto Lucio Dalla.
Trilogia di New York

Mi fu regalato tanti anni fa, appena uscito. Lo lessi e oggi ne ho solo un ricordo confuso.
Mi dovette piacere, perchè subito dopo lessi, sempre di Paul Auster, “La musica del caso”, che invece ricordo piuttosto bene.
Più di recente ho letto Baumgartner, il suo ultimo romanzo, e così, quando me lo sono trovato davanti, in libreria, ho deciso di rileggere “Trilogia di New York”, che è come se mi fosse rimasto qualcosa di irrisolto.
E, infatti, mi toccherà stare molto attento, perchè nelle prime cinque pagine sappiamo che il protagonista, Quinn, è uno scrittore che ha lasciato la buona letteratura e che ormai per vivere scrive gialli seriali, uno all’anno. Quinn scrive con lo pseudonimo di William Wilson e si è ormai immedesimato in Max Work, l’investigatore privato protagonista dei romanzi di William Wilson.
E così siamo già a tre protagonisti potenziali, quando alla voce narrante arriva una telefonata di qualcuno che vuole parlare con l’investigatore privato Paul Auster.
Sono molto curioso.
L’enigma di Majorana

Stefano Mancini, nella Feltrinelli di viale Marconi, mi ha chiesto, mentre sbirciavo fra i libri esposti, se poteva presentarmi il suo libro.
Circa quarant’anni, modi educati, contento che lo stessi a sentire – probabile fossi il primo, la libreria aveva appena aperto – mi ha esposto in breve il succo, ma confesso che ascoltavo poco, perchè il “modo” mi aveva già conquistato e avevo già deciso di comprarlo.
Di Majorana ha già scritto Sciascia, che però cercava di intuire una verità, mentre qui si tratta di un thriller, e il fatto che il giovane matematico sia misteriosamente scomparso rende possibile ogni costruzione intorno.
Deve aver contato anche una forma di solidarietà, visto che ho un romanzo in uscita a maggio (a maggio?).
Gli ho chiesto come avesse avuto quello spazio: iniziativa dell’editore, infatti la settimana prossima sarà in un altra libreria.
Legge sopratutto gialli e thriller, “per migliorare”, gli è piaciuto “I leoni di Sicilia”.
Sono curioso.
Cosa resta di noi

La Versilia, una coppia che non riesce ad avere figli, composta da un bagnino diventato imprenditore per matrimonio, una donna bellissima che ne è diventata la moglie e si dedica alla carriera di scrittrice e poi di presenza televisiva, l’arguzia toscana quando diventa becera, un’impiegata innamorata dell’uomo sbagliato.
È quest’ultima che muore. Anzi scompare. Tranquilli: succede nelle primissime pagine, quindi non svelo niente.
La scrittura va via liscia, i personaggi sono bel delineati, anche i minori, come l’amico del bagnino, il padre del trucido.
Per la parte “giallo” la storia è ben condotta, ma nelle ultime pagine il crash finale è poco sostenuto dalle premesse e dalla logica e anche le evoluzioni di qualche personaggio – sopratutto la moglie – sono decisamente poco credibili.
Che dire? Gradevole, posso provare con altri.
Il quasi giallo Sellerio è ormai quasi un genere: scrittori dallo stile scorrevole che raccontano storie che fanno pensare a qualche ambizione maggiore rimasta confinata. Di persona Giampaolo Sini – conosciuto ad una “lectio magistralis” sul cui titolo lui stesso ironizzava – ha l’aria simpatica, confermata dalla esplicita dichiarazione di sapere esattamente dove – letterariamente – sta e dove vuole stare.
APPREZZABILE
Homo Deus – Breve storia del futuro

” certo possiamo scegliere quali azioni compiere, ma possiamo scegliere quali desideri avere? E se questi sono determinati da processi biochimici in che cosa consiste esattamente la libertà? “
Un concentrato di intelligenza, come ogni volta che un rigoroso esame del presente e del passato induce a porsi domande epocali, senza la pretesa di avere le risposte.
Non riesco a riprodurre i percorsi con i quali Harari arriva ad una serie di – ipotetiche e potenziali, sia ben chiaro – previsioni, cerco di limitarmi ad esporne alcuni assunti.
L’evoluzione tecnologica consente quantomeno di “pensare” che l’immortalità sia possibile, insieme al raggiungimento della felicità, ma questi bei progetti sembrano presupporre un’economia a crescita infinita che probabilmente ci condurrà all’estinzione, per mano di creature superiori all’homo sapiens che noi stessi stiamo cominciando a generare.
Uno degli assunti, mi pare sia proprio il principale, su cui poggiano gli argomenti di Harari è che i neuroscienziati avrebbero dimostrato che non esisterebbero gli individui, ma che ogni essere umano sarebbe costituito di un insiemi di algoritmi, sopratutto biochimici. Ad esempio, le emozioni – “provare” qualcosa – sarebbero prodotte da una serie di algoritmi che sono stati essenziali per lo sviluppo dell’homo sapiens, secondo i principi di Darwin della sopravvivenza del più adatto.
Se “sentire” deriva da algoritmi biochimici, allora anche gli animali “sentono”, e non si può escludere che “entità” di provenienza informatico/elettronica possano/potranno “sentire”. La superiorità dell’homo sapiens è data dalla nostra capacità di collaborare e di farlo con estrema duttilità, a differenza ad esempio delle formiche o delle api,Altra superiorità dell’homo sapiens sta nella capacità di raccontare storie, e dunque di dare un senso al passato, fare previsioni per il futuro. costruire entità immateriali e intersoggettive come il denaro, gli dei, etc, con funzioni rilevantissime nella nostra esistenza.
Fra queste entità, quella che da qualche secolo ha prevalso, è l’umanesimo, che riconosce una serie di diritti fondamentali a ciascun uomo, fra cui la capacità di realizzarsi al meglio. Qui il punto è in che cosa consisterebbe la libertà: di certo possiamo scegliere quali azioni compiere, ma possiamo scegliere quali desideri avere? E se questi sono determinati da processi biochimici in che cosa consiste esattamente la libertà?
L’evoluzione dell’economia, d’altra parte, tende a rendere sempre meno utili i singoli individui, o meglio la massa dei singoli individui, che possiamo constatare come vengono sempre più rapidamente sostituiti da algoritmi non-umani, anche se creati da uomini. Ma a mano a mano che questi nuovi organismi diventano “capaci di apprendere” sempre meno l’intervento umano sarà necessario. Basta pensare alla medicina: una volta immagazzinati una mole sterminata di dati di tutti gli individui, un computer potrà fare nella maggior parte dei casi diagnosi più accurate e proporre terapie più efficaci della maggioranza dei singoli medici.
La nuova religione dell’umanità potrebbe essere basata appunto sui dati. I Datisti sostengono che un computer che conosca la maggior parte delle informazioni significative su di me potrebbe essere in grado di conoscermi meglio di me stesso e di anticipare i miei desideri. Il che è ciò che, in forma ancora largamente grezza, già fanno i vari Google, Facebook, Amazon etc. Non si può perciò escludere che saremo governati “per il nostro bene” da macchine da noi costruite, che si saranno da noi emancipate.
Sicuramente ho tagliato con l’accetta concetti che Harari espone sempre con un interessante corredo storico e scientifico. Difficile condividere la tesi centrale; mi fa tornare alla mente suggestioni liceali / universitarie del Barkley che considerava la realtà come “meri fasci di sensazioni” e l’individuo come “insieme di algoritmi”. Difficile anche confutarla.
Mattino e sera

Se lo avessi letto senza conoscerne l’autore, dovendo indovinare, avrei detto Hemingway. Per lo stile, non per altro.
” Come è andata ieri la pesca? dice Johannes Ieri ho fatto davvero un colpaccio, dice Peter Un colpaccio? dice Johannes Avresti dovuto esserci ieri, Johannes, dice Peter Avresti dovuto esserci, sì, dice “
E prosegue per un pò. La punteggiatura è quella che vedete qui, non ho colto il significato della mancanza dei punti e lo stesso andare a capo e ricominciare con la maiuscola.
Nè ho colto il significato del far cominciare alcune frasi, dopo un a capo, con “e” (minuscolo).
A parte queste curiosità, non saprei definirle altrimenti, grammaticali (?), dopo le prime trenta pagine piene di ripetizioni stavo per abbandonare, e stavolta il richiamo era ad “Aspettando Godot”. Ho deciso di proseguire, visto che in totale si tratta di 152 pagine e pure di piccolo formato, e ho fatto bene.
Da un certo punto in poi è molto chiaro dove andrà a parare, e comunque qui non lo svelo e mi limito a dire che vale la pena arrivare alla fine, perchè la fine, anche se nota da almeno metà, riesce ad essere commovente, pur con tutti gli scherzi di punteggiatura e i dialoghi ripetuti.
Sonata a Kreutzer
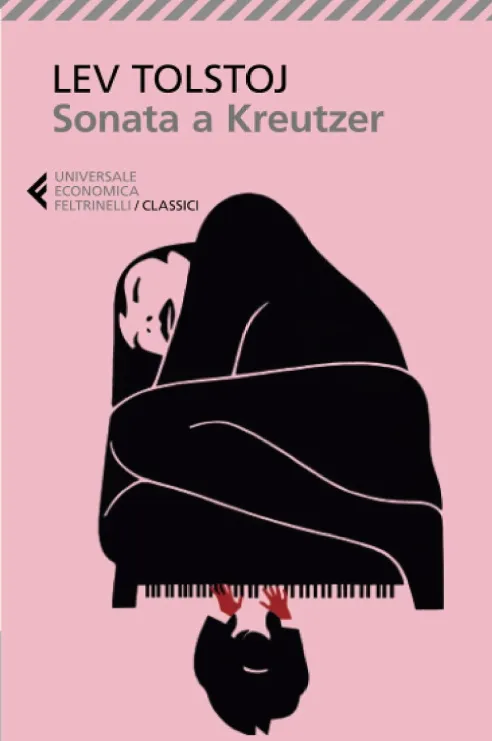
Chi non ha, almeno una volta nella vita, sognato di uccidere la moglie (o il marito, fidanzato/a, etc)? Magari ne ha solo desiderato la morte, per non dover prendere la decisione di lasciarlo/a?
Sonata a Kreutzer è la storia di un uxoricidio effettivo raccontato dall’assassino – assolto perchè il tribunale riconoscerà che aveva agito per motivi di onore – ad un passeggero incontrato casualmente in treno.
Ho letto abbastanza sconcertato: tutta la prima parte è un concentrato di luoghi comuni sul matrimonio tomba dell’amore e sulla misogenia: “…chi fa la prostituta per un periodo di tempo limitato viene disprezzata da tutti, e chi lo fa per periodi più lunghi gode del massimo rispetto.” Vero è che non conosco i costumi russi del periodo, e quindi non sono in grado di valutare se quelli che oggi mi appaiono luoghi comuni allora potessero essere letti come concetti avanzati.
Un primo effetto, comunque, è un sospiro di sollievo: un po’ di strada verso un mondo più civile l’abbiamo fatta. Poi mi è venuto un dubbio: forse Tolstoi non si identifica con il protagonista, e lo vuole ridicolizzare. Dal tono dell’insieme mi pare poco probabile, e l’impressione che mi resta è quella di un alter ego che sfoga nella scrittura ciò che non mette in pratica per motivi morali, sociali o che so io.
Dunque, la prima parte è la descrizione dei disastri del matrimonio.
Nella seconda, inopinatamente, irrompe invece una gelosia – che a me pare tanto irragionevole quanto lontano affettivamente il protagonosta si sente dalla moglie – che porterà alla tragedia finale. Tale irragionevolezza mi ha fatto considerare l’ipotesi che il tema del racconto sia non tanto la donna e il matrimonio quanto dove possono portare sentimenti non controllati dalla ragione.
Forse in queste diverse, tutte possibili chiavi di lettura, sta la grandezza del racconto, che mi sono goduto anche per alcuni particolari perfidi, come, nelle pagine finali: la preoccupazione del marito assassino, mentre sta sventrando la moglie, di non risultare ridicolo se corresse dietro al rivale a piedi scalzi e, poco dopo, mentre medita se usare contro di se la pistola, l’attenzione ad infilarsi almeno le pantofole quando lo avvertono che la polizia sta arrivando.
Il nostro traditore tipo
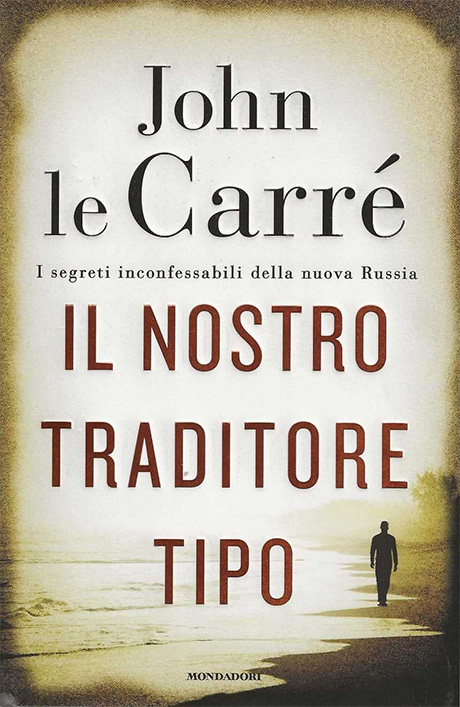
Credo di aver letto tutto Le Carrè. Il che, per quanto mi riguarda, è vero soltanto anche per Kundera.
Anche se Le Carrè ha scritto soltanto romanzi di spionaggio (più un giallo, poco riuscito), non lo considero uno scrittore “di genere”, ma un grande scrittore.
Anche ne “Il nostro traditore tipo” c’è tutto quanto me lo fa amare: personaggi credibili con spessore psicologico sempre ben definito, una storia un cui un outsider (questo soprattutto nei romanzi scritti dopo il 1989: prima, i protagonisti sono soprattutto professionisti dei servizi) si trova in qualcosa di cui non può afferrare le dimensioni e tuttavia decide di navigarci, anche se ciò comporterà rischi estranei alla propria vita usuale.
La storia è credibile e raccontata in quel modo che fa venire voglia che arrivi la sera per scoprirne il seguito. Insomma, uno di quei libri che danno la frenesia e i timore – perchè: e poi che cosa leggerò? – di arrivare alla fine.
Le Carrè è da leggere tutto, senza eccezioni.
La vita è altrove

Un romanzo che segue la breve vita di Jaromil, il poeta convinto di essere capace di costruire una coerenza fra il lirico e il rivoluzionario, nella Praga degli anni quaranta, mentre si afferma il “socialismo” di marca sovietica.
Le donne di Jaromil, con l’eccezione della madre, non hanno un nome: sono la rossa, la cineasta. Anche gli uomini è più facile ricordarli come il pittore, il poeta sessantenne, il poliziotto figlio del bidello, e alla fine, per il lettore, Jaromil sarà solo “il poeta”.
Sono “tipi” non tanto dell’epoca quanto dell’umanità, maschere a contorno di una vita di quelle – come, forse, sono un po’ tutte le nostre vite – che si vogliono gloriose e che, se non ci fossero state, nessuno se ne sarebbe accorto, se uno scrittore non avesse deciso di scriverne in un romanzo.
D’altra parte, se “…l’uomo non può in alcun modo saltar fuori dalla propria vita, il romanzo è molto più libero.”
Negli ultimi due capitoli il punto di vista sui personaggi cambia, eppure li riconosciamo tutti, nelle ultime pagine feroci e tenerissime.
Come tutto Kundera.
TEORIA DEGLI INFINITI
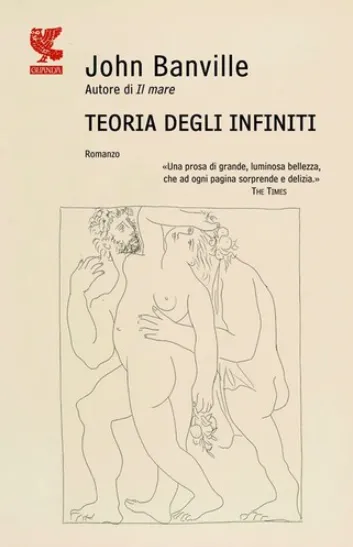
Non c’è un protagonista, se non il grande vecchio morente, sullo sfondo, e la famiglia intorno al patriarca con Mercurio – sì, il dio Mercurio, o Ermes per i greci – narratore inconsueto…
La scrittura è protagoniosta, soprattutto quando impasta gli interventi dispettosi e lussuriosi degli dei con le miserie umane.
Custode di mio fratello

Un primo criterio per stabilire – un mio criterio, si capisce – se un libro merita di essere letto e se, quindi, è valsa la pena averlo fatto pubblicare, pubblicare, non scrivere, chè scrivere vale la pena sempre, è se mi fa venire voglia di continuare, mentre lo leggo, e mi fa dispiacere che sia finito quando arrivo alla fine.
Un altro criterio è che racconti una bella storia, con personaggi che si capisce chi sono.
Infine, una scrittura interessante, che può essere levigata e scorrevole o puntuta e graffiante, purchè trovi il modo di arrivarmi almeno qualche volta sotto pelle.
“Custode di mio fratello”, di Mario Santamaria ha soddisfatto il primo dei miei criteri: da quando l’ho preso in mano mi è rimasta la voglia di riprenderlo e di arrivare alla fine.
Circa la storia e i personaggi, beh, la storia c’era e i personaggi pure, la sorpresa è stata che la scrittura, che aspettavo come il pezzo più forte, avendo già letto il romanzo precedente e anche tanti post su Facebook che si distinguono proprio per la scrittura accurata e intensa, la scrittura mi ha affaticato.
Purtroppo.
Non c’è stata pagina in cui non sia dovuto tornare indietro a rileggere almeno un paragrafo e da un certo punto in poi ci ho rinunciato e mi sono accontentato di proseguire a intuito.
Per quanto, ancora adesso sospetto che Caio e Xud siano la stessa persona ma non ne sono certo.
Ma perchè non poteva essere scritto come la bella pagina e mezzo di “Ringraziamenti”, lineare senza che diventi banale?
Ma, poi, forse non è la scrittura in sè, forse è quell’eccesso di gioco a nascondino con il lettore, che ti butto una cosa qui che proprio non la puoi capire, caro lettore, e fra dieci pagine vediamo se sei stato attento e cogli il collegamento con quest’altra cosa.
Fine delle considerazioni di stile.
Circa il contenuto, credo sia ben reso sopratutto il personaggio del carrozziere fascista puro, forse con un eccesso di apprezzamento, se no magari un po’ di entrate economiche sarebbero trapelate dal molto verosimile commercio di appartamenti di uno che è considerato il boss dei blocchi.
Meno credibile il fratello chirurgo estetico, ancora meno la sorella adottiva – non svelo niente, sta scritto nel risvolto di copertina – che davvero non sono riuscito a capire alla fine con quale livello di danno se la sia cavata, a parte aver incontrato la spregevolezza presente dei due fratelli, e quella passata che ci viene fatta intuire, tanto che alla fine il personaggio più simpatico mi arriva il pessimo padre fascistone che se l’è goduta alla grande a Londra, non solo frocio ma pure con l’amante ricco ebreo. Perchè pure la madre, insomma…
Che dite, che non si salva nessuno? È precisamente così, e forse ha voluto essere questo il segnale dato allo spirito del tempo.
La scuola cattolica
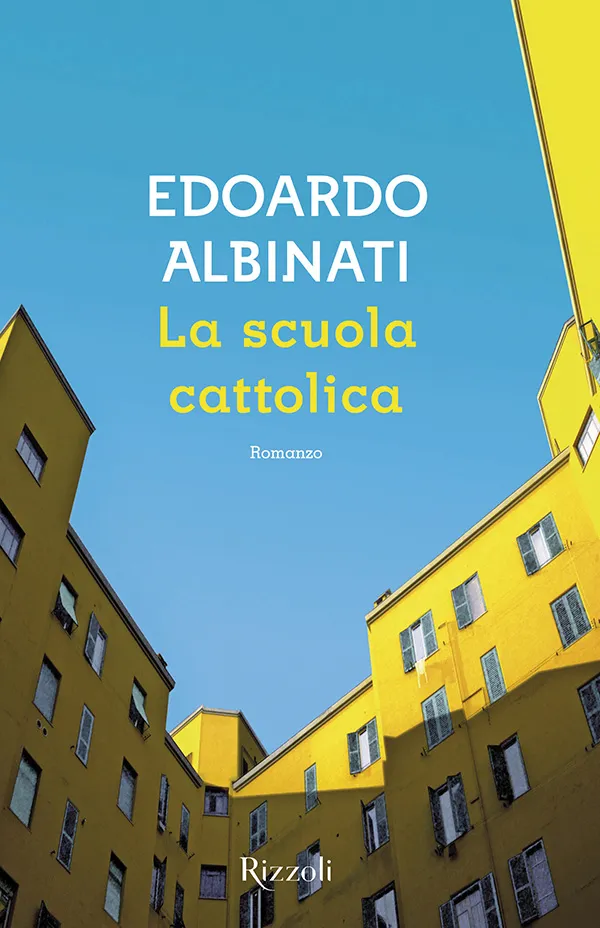
Tre sigle percorrono questo romanzo di più di mille e quattrocento pagine: QT, SLM, DdC. Rispettivamente, il quartiere Trieste, il San Leone Magno, il delitto del Circeo.
Anni settanta, tre ragazzi incontrano due ragazze, le portano in una villa sul Circeo, le seviziano per due giorni fino a ucciderle.
Le mettono nel portabagli della macchina e tornano a Roma a prendersi un gelato. Una delle due ragazze però ha solo finto di essere morta, batte dall’interno del portabagli, qualcuno la sente, viene salvata, due dei tre ragazzi vengono immediatamente arrestati, del terzo non si saprà più niente fino a oggi.
Ci arriviamo dopo più di quattrocento pagine. In realtà, le pagine sui fatti dei delitti – ce ne sarà un altro – sono davvero poche e senza mai che si indulga in quel genere di descrizioni che fanno la fortuna della cronaca nera dei giornali.
Sono nato in quel quartiere, so dov’è il SLM anche se non l’ho frequentato ma sono stato in un collegio gestito da religiosi, conosco quel clima, quel genere di persone perchè, dopo aver abitato altrove, ho lavorato lì vicino e i miei figli hanno frequentato un asilo del quartiere e poi le elementari a Villa Paganini. Albinati mi ha restituito in pieno quel clima, con in più una quantità di sfaccettature le più diverse.
L’autore ci è nato, ci è vissuto, ha frequentato il SLM e ha conosciuto gli autori del DdC, i loro fratelli e sorelle, gli amici, i genitori, gli insegnanti. Ha sentito il bisogno irrefrenabile di scrivere quando uno dei tre, dopo aver scontato anni di galera ed essere uscito per buona condotta in semi libertà – era diventato consulente psicologico – aveva ammazzato due donne, madre e figlia, la figlia di quattordici anni. Di nuovo senza alcun motivo che lo posso fare, lo faccio.
Eppure non è la riflessione sui delitti il centro del libro. Ne è invece lo spunto per un’analisi profonda, molto profonda, del mondo maschile, in un percorso a spirale con le curve che si allargano sempre di più fino ad abbracciare, in questa ricerca, la borghesia, la classe media, la religione e la sottile arte di rovesciare il senso comune per cui, per dirne solo una, chi muore passa a miglior vita.
Due capitoli, in particolare, dicono del grande scrittore.
Dopo aver fatto complessi ragionamenti sulla quasi ineluttabilità genetica del maschio a essere stupratore e assassino, un capitolo descrive una scena di sesso, bella, vera, alla fine della quale “Le sue natiche rilucevano chiare nel buio, e lei sembrava morta, non si muoveva più, non respirava“.
Sul finale, l’autore bambino in settimana bianca si ammala, un prete amorevole se ne prende cura, noi vediamo come se ne prende cura ma non sappiamo come se ne prende cura.
L’autore – presente in prima persona nel romanzo – non si fa sconti, ma davvero non se ne fa, non come quelli che si trattano malissimo mentre strizzano l’occhio al lettore: visto, come sono del tutto trasparente anche nel peggio di me?
Sembra spietato, verso i suoi personaggi / persone, tranne che verso la famiglia Rummo, della cui tragedia racconta in un altro bellissimo capitolo, e che ritrova sul finale, alla messa di natale di mezzanotte, che gli dà l’occasione di concludere il romanzo con una parola inaspettata, che qui non rivelerò.
Non è una lettura leggera, ma è una lettura che prende, che fa venir voglia di andare avanti perchè è vero che sta esprimendo lo stesso concetto ma lo sta facendo con parole nuove, con sempre un aggiunta di significato, un approfondimento marginale ma vero. È uno di quei libri che quando lo hai finito ti lascia la nostalgia di un’esperienza che è passata e che è stato così bello viverla.
I maschi dovrebbero leggerlo per specchiarvisi, come ho cercato, non senza difficoltà, di fare, le donne dovrebbero leggerlo per imparare qualcosa sul maschile e poterlo, qualche volta, compatire.
Il disperato bisogno di senso, tipico del romanzo, trionfa nelle conclusioni che noi tiriamo sul nostro passato, fornendo un alibi fantastico per qualsiasi cosa sia accaduta ma anche per quelle che debbono ancora accadere; in fondo la letteratura è un’assicurazione sulla vita per abbandonare il tentativo di costruirsene una diversa, di costruire un altro me stesso migliore o più coraggioso.
È questo, sempre, ogni romanzo: la narrazione di un’infelicità.
Calcoli e rompicapi

La prima copertina illustra un famoso esempio di “decisione impossibile”: sta arrivando un carro merci, se continua la sua corsa senza interventi travolgerà 5 persone, fra cui una bambina.
È lecito (morale, ammissibile, etc) azionare lo scambio, in modo che invece di 5 persone ne sia travolta soltanto una?
I due testi, insieme, insegnano che possiamo proporci di essere sempre onesti e giusti, ma che a quanto pare non basta avere principi saldissimi, perchè è sempre possibile immaginare situazioni nelle quali principi ai quali diamo lo stesso valore vengono in conflitto.
E allora SEMPRE, sempre, la scelta sta solo a noi, e a volte solo dopo averla fatta potremo riconoscere che cosa ci ha guidato, e a volte potremo scoprire che non è detto siano stati i principi, a guidarci.

La sovrana lettrice
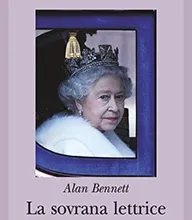
Grande preoccupazione a corte: la regina, vicina agli ottanta, ha cominciato a leggere libri!
Non che questo la distolga da suoi doveri, non che la induca a comportamenti inappropriati, tuttavia, nell’entourage, cercano rimedi.
Ne trovano di provvisori, come far scomparire qualche addetto a cui la regina si è forse affezionata, anche se la sua regale posizione non le permette nemmeno di cercarlo.
Il primo ministro si tranquillizza e immediatamente dopo si turba quando la regina fa sapere, in occasione della festa per gli ottanta, che ha intenzione di passare dalla lettura alla scrittura: non di viaggi, nè di un memoire, forse di un saggio e, chi lo sa, forse di un romanzo, perchè no.
Il primo ministro è sbiancato, e non ha ancora letto l’ultima riga di queste deliziose cento pagine di Alan Bennet, sempre soave e pungente.
La vegetariana

Il romanzo – 176 pagine – è diviso in tre parti: nella prima il protagonista è il marito, nella seconda il cognato, nella terza la sorella.
Marito, moglie, sorella di Yeong-hye: la vegetariana.
Il titolo può trarre in inganno, da qualche parte ho letto commenti insensati del genere “hai visto che succede a non mangiare più carne?”.
Si tratta della storia della follia di una donna, che parte da alcuni sogni spaventosi. Ma l’autrice non vuole condurci nell’abisso che può aver prodotto quei sogni e i comportamenti succesivi, si limita a mostrarci il baratro del presente e come se ne varca, inesorabilmente, la soglia.
La scrittura è “povera”; mi sono interrogato sulla difficoltà di tradurre dal coreano, ho cercato in giro e ho scoperto che in realtà il testo italiano è una traduzione della iniziale traduzione inglese, a quanto pare fonte di forti polemiche in Corea e non solo.
Ho immaginato di poter leggere la seconda parte, di gran lunga la più bella, in originale e mi è piaciuto convincermi di come – forse – sarebbe stato visionario il movimento di due corpi dipinti di fiori mentre fanno all’amore, uno coinvolto allo spasimo e l’altro partecipe per inerzia. Una specie di violenza consensuale, se mi si passa l’ossimoro.
Inquietante. Peccato non conoscere il coreano: ho provato con i film di Kim-Ki-Duk (da non perdere) sottotitolati ma temo non sia sufficiente
Per sempre

La voce carezzevole di Roberto Ciotti – sono già undici anni che è morto, mi pareva l’altro ieri e in effetti pure il Big Mama non c’è più da un po’ – con il suo tenero inglese pensato in italiano e la straordinaria chitarra si è rivelata un’ottima abbinata con le ultime pagine di questo romanzo.
Mario Santamaria diceva che la trilogia di Bascombe era imperdibile, e la cercherò, visto che questo pare essere il quarto con lo stesso protagonista.
Franck Bascombe, che per oscuri motivi il figlio Paul chiama Lawrence.
Paul ha la sla e il padre lo accompagna nella clinica dove sperimentano una nuova cura e, visto che non lontano c’è il monumento con le facce dei quattro presidenti scolpiti nella roccia, perchè non andarli a vedere?
La storia è tutta qui e mi ha tenuto attaccato per tutte le trecentocinquanta pagine nel midwest di motel scalcagnati, venditori di macchine usate, bar di vario genere e tutta l’umanità intorno.
Paul, poi, è uno simpatico che non se la tira per il fatto della sla e il padre pure non gliele manda a dire nè lo tratta con condiscendenza per via della sla.
Fra l’altro, gli è toccata una figlia femmina gay di destra e che può capitare di peggio a un padre?
“Ti piace rifletterci, sulle cose, eh Franck?”
“No seguo l’istinto e poi trovo le motivazioni. Come tutti.”
Questo un pezzetto di dialogo (a memoria) e sì, nemmeno Richard Ford, che pure la sa lunga, se la tira.
Da leggere.
150 ACRI

Un libro faticoso da leggere, e in questo caso “faticoso” vale come apprezzamento, perchè il romanzo restituisce, fa vivere, tutta la fatica di chi, reduce dalla guerra di Corea – siamo quindi a metà degli anni ’50 del ‘900 – è andato a stabilisrsi in Alaska per avere un posto tutto suo.
Sono i 150 acri che Lawrence sceglie sulla carta perchè gli piace che in mezzo ci sia un lago. E quindi la fatica di riconoscerli, di perimetrarli, di dissodarli almeno in parte perchè il nascente Stato dell’Unione gli confermerà la proprietà solo se almeno il 10% risulterà essere stato coltivato. O era il 20%? O erano due culture e non solo una?
L’incontro con Marie, poco più che adolescente, che si scelgono per la vita in quel luogo sormontato da un picco, abitato da orsi pericolosi e alci inafferrabili, dove il primo inverno lo passano dentro a un furgone in qualche modo attrezzato.
Non si conoscono realmente: si studiano, si sopportano, si amano, nuotano nel lago, costruiscono una casa senza sapere come si costruisce una casa, e la nascita di un figlio sembrerà meno importante dell’intestazione sulla carta a uno solo o a entrambi di quei 150 acri.
Poche volte mi sono trovato, mentre leggevo, così immerso in quel freddo implacabile, in quel silenzio, in quel caldo esagerato della stufa, in quella difficoltà di comunicare e in quella tensione per cercare di farcela insieme a ogni costo.
Da leggere
SENTIRE E CONOSCERE
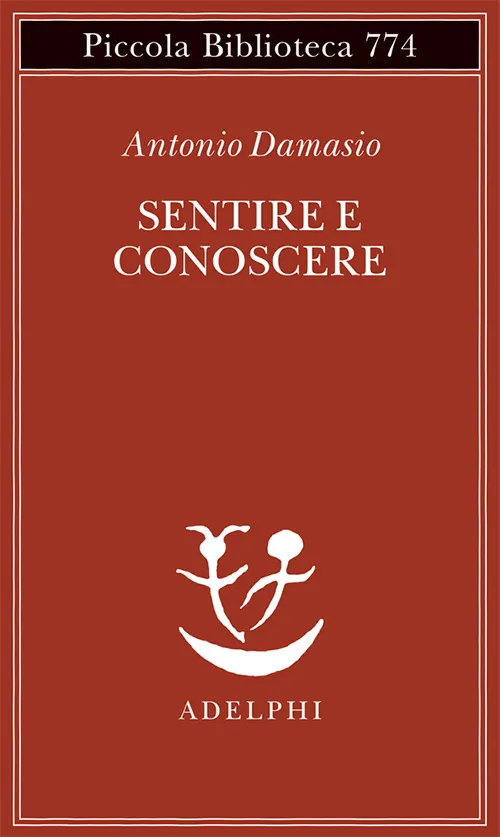
Meno di duecento piccole pagine dense di contenuto come poche.
Mi limito ad alcune definizioni che mi pare di aver capito meglio: intuito, chè alcuni concetti non li padroneggio.
“Intelligenza”, per Damasio, è quella competenza non esplicita, della quale sono dotati anche gli organismi unicellulari, che punta a mantenere la vita al meglio (omeostasi).
“Sensibilità” è la capacità (non ancora cosciente) di rilevare stimoli.
La “Mente” implica l’esistenza di un sistema nervoso capace di formare rappresentazioni e immagini dell’esterno e anche di costruire un mondo interno.
Le “Emozioni” sono quindi azioni interne prodotte da eventi percettivi.
I “Sentimenti” sono la condizione per creare il Sè:
sono la reazione ai contenuti mentali, sono il risultato del dialogo fra i processi chimici del corpo e l’attività bioelettrica dei neuroni. I sentimenti offrono alla mente gli incentivi ad agire secondo i segnali positivi o negativi (in termini di omeostasi) provenienti dalla mente.
La “Coscienza”, infine, arricchisce i processi mentali, identifica la stretta relazione mente / corpo e permette la conoscenza. Come si produce la coscienza resta un – parziale – punto interrogativo, esposto in uno degli ultimi capitoli dal titolo “La corteccia cerebrale e il tronco encefalitico nella costruzione della coscienza”.
Molto stimolante.
La banda dei brocchi
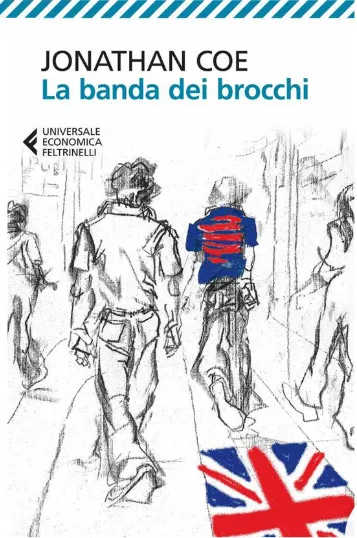
Sono le storie di un gruppo di ragazzi nel periodo delle scuole superiori, con intermezzi che coinvolgono i rispettivi genitori e insegnanti.
Si è fatto leggere, ma arrivare alla fine è stato faticoso.
Il decoro

Lo stato di totale smarrimento di un gruppo di amici newyorkesi, intellettuali più che benestanti anche se non straricchi, dopo la vittoria di Trump.
La casa del sonno

La costruzione dell’intreccio è magistrale.
L’alternarsi di capitoli pari e dispari a vent’anni di distanza, con tutti i fili al posto giusto e senza mai lasciare il lettore disorientato è affascinante.
Eppure, l’emozione, quando potrebbe prenderti, resta sospesa, perchè quella che appariva una storia drammatica non capisci più bene se non sia invece virata nel grottesco.
Nei corsi di sceneggiatura si insegna che in una storia una coincidenza ci può stare, due diventano sospette, tre rendono l’insieme poco credibile: gli ultimi capitoli de “La casa del sonno” sono così pieni di coincidenze che viene da pensare sia stato questo il modo per strizzare l’occhio al lettore e dirgli non mi prendere troppo sul serio, mi ci sto divertendo.
Il che mi lascia il sapore di un chè di immorale, visto che la storia qualche emozione aveva suscitato.
La vita davanti a sé

Momo è un ragazzino arabo di dieci anni, ma forse undici, e strada facendo scoprirà che potrebbe averne anche quattordici.
Momo vive con Madame Rosa che, all’ultimo piano di un condominio senza ascensore, alleva una mezza dozzina di flgli di puttana.
Alla lettera: sono figli di prostitute che, per le leggi allora vigenti, hanno paura che i servizi sociali glieli tolgano e li diano in affido, e dunque li consegnano a Madame Rosa affinchè se ne prenda cura.
Per Madame Rosa è un lavoro: ogni madre le invia periodicamente soldi, ma Madame Rosa continua a tenere i bambini anche quando le madri scompaiono. Madame Rosa è una vecchia ebrea nera che ci sta poco con la testa, ogni tanto rivive epoche lontane ed è piena di acciacchi. Momo se ne prende cura alla fine più di quante cure abbia ricevuto.
Momo si è costruito un linguaggio tutto suo e una visione del mondo del tutto singolare.
Momo soffre per quanto Madame Rosa si deteriora: Madame Rosa gli ha detto che c’è una faccenda che si chiama Ordine dei medici che è fatto apposta per farle delle sevizie e impedirle di morire. Perciò Momo si arrabbia con il dottor Katz, talmente vecchio da dover essere portato in braccio per le scale per visitare Madame Rosa, quando gli dice che non la può abortire. Momo se la caverà a modo suo, e alla fine ci sarà anche chi si occuperà di lui.
PS: Romain Gary ha vinto il Goncourt con questo romanzo ma con uno pseudonimo: si è saputo solo qualche mese dopo che si è suicidato con un colpo di pistola. Era stato il marito di Jean Seberg, suicida un anno prima. Ha lasciato un biglietto: “Nessun rapporto con Jean Seberg, i patiti dei cuori infranti sono pregati di rivolgersi altrove“
ACCIAIO

Dopo poco i personaggi sono persone che conosci, e le cose che succedono, le vicende che li toccano sono cose che succedono a persone che conosci.
TEMPO DI UCCIDERE
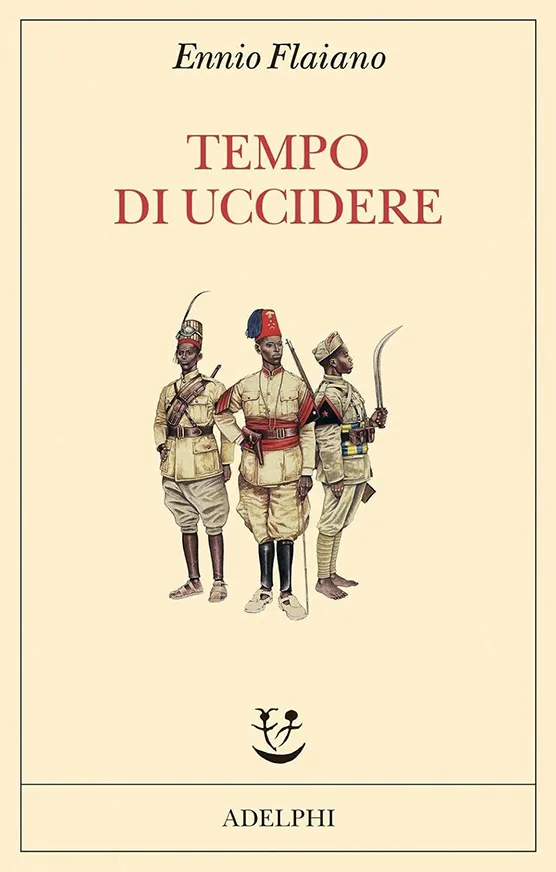
Un camion rovesciato su una strada polverosa dell’Etiopia degli anni trenta, quelli dell’Italia ha un impero.
Il giovane tenente, dopo aver aspettato che passi qualche camion, si stufa, lascia lì il soldato che lo accompagnava e si avvia ad attraversare una valle che lo porterà dove corre una strada più frequentata.
Il protagonista potrebbe essere uno dei personaggi di Joseph Roth – di altra epoca e altre ambientazioni – con i quali sembra avere in comune una cupa neghittosità che lo porta a non stare mai davvero in contatto con il mondo che lo circonda, a sfidarlo e a ritrarsene ma sempre in modi che appaiono casuali anche quando sembrano meditati.
Una tragedia si compirà, altre saranno sfiorate e non si mai bene come evitate, senza che il protagonista sembri essere consapevole di che cosa gli succede intorno e che cosa producono le sue azioni.
Così vaga, fra boscaglie infide di iene e fetore di carcasse di muli, fino a una città portuale dove le vie d’uscita non si trovano.Tornerà alla base? La sua assenza è stata notata? Sarà sanzionata? Tutto scorre con sullo sfondo le atrocità verso i guerrieri africani, le piccolezze quotidiane di chi si trova a esercitare un briciolo di potere lontano dall’esistenza di fame in patria. La vicenda del protagonista sembra parallela e in qualche misura simbolica rispetto a quella dell’avventura africana di un esercito comandato da cialtroni tanto male equipaggiati quanto feroci.
Alla fine cammina a fianco di un sottotenente e sente l’odore della pomata per capelli di quello:
“… dal profumo delicato, infantile, ma il caldo la stava inacidendo. Una pessima pomata, che il caldo di quella valle faceva dolciastra, putrida di fiori lungamente marciti, un fiato velenoso. Affrettai il passo, ma la scia di quel fetore mi precedeva“.
Queste, sopra, le ultime parole del romanzo, che ne restituiscono in pieno l’atmosfera.
Una questione privata

Comincia come una storia d’amore di Milton per Fulvia e di amicizia fra Milton e Giorgio.
Milton non fa altro che pensare a Fulvia, che dalla villa di campagna dove i genitori l’avevano mandata è tornata in città, ora ritenuta più sicura.
Milton è un partigiano ventenne, con l’amico Giorgio sono i soli di provenienza borghese, entrambi universitari.
Quando gli capita di passare davanti alla villa non può fare a meno di avvicinarvisi e di chiedere di Fulvia alla governante che è rimasta lì.
Le parole della governante, ambigue circa la relazione che potrebbe esserci stata fra Fulvia e Giorgio diventano il motore del romanzo, perché Milton deve assolutamente incontrare l’amico e farsi spiegare, capire.
Perciò lo cerca alla base della loro brigata ma si è spostato in un altro gruppo e quindi Milton si muove in quell’inverno fangoso che tira giù nebbie che non ti puoi vedere la punta della scarpa. Gli incontri con i Rossi – Milton è di una brigata badogliana – con i contadini di questa o quella cascina, gli scambi di racconti fra partigiani accompagnano i suoi movimenti, sempre più faticosi, con tutto quel fango che gli si aggruma addosso.
Quando finalmente raggiunge il gruppo di Giorgio l’amico è rimasto attardato e non arriva e non arriva finché qualcuno dice che l’hanno catturato i fascisti ma nessuno è sicuro di niente.
Milton allora cerca fra le brigate chi abbia un prigioniero fascista per poterlo scambiare con l’amico ma niente da fare e allora si ingegna a procurarselo lui.
Da qui il racconto quasi si incattivisce: il prigioniero muore da una pistolettata (involontaria?) di Milton, una maestra fascista viene rapata, un ragazzino fucilato dai fascisti.
Di Giorgio non si sa ancora niente di preciso e, mentre Milton va verso Alba senza più un piano di azione, avendo perso il prigioniero da scambiare, si imbatte in un gruppo di fascisti dai quali scappa e queste ultime pagine tra colline scivolose di fango, corsi d’acqua gelidi, ponti minati sono fra le più realistiche che io abbia letto di una fuga quando il fiato manca e il corpo non risponde finché Milton, con le pallottole che gli schizzano intorno, riesce a rifugiarsi in un bosco “…e a un metro da quel muro crollò”.
Queste, le parole finali.
Vivo? Morto? Chissà. D’altra parte, non sappiamo come è andata fra Fulvia e Giorgio, non sappiamo di Fulvia, non sappiamo qual è la spinta principale che induce Milton a rischiare la vita per salvare Giorgio, non sappiamo la sorte di Giorgio.
Non sappiamo niente delle “cose che sono successe” alla fine di queste centoventi pagine. E, tuttavia, sappiamo molto dei moti emotivi dei personaggi e anche di che cosa dev’essere stata la Resistenza, che pure qui rimane uno sfondo.
Uno di quei romanzi da leggere assolutamente.
Jazz
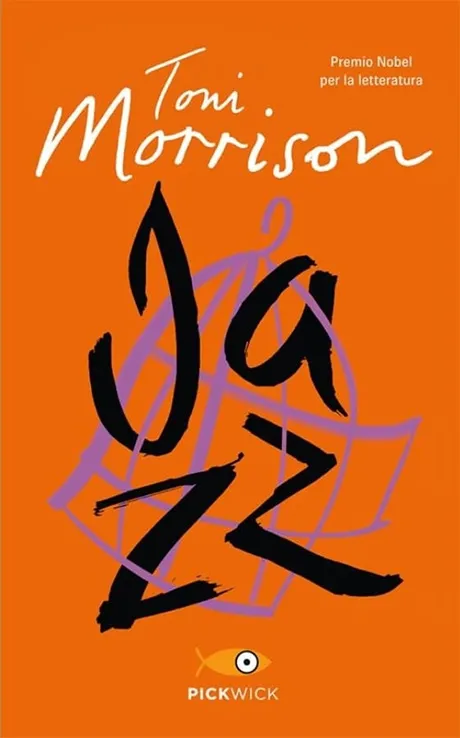
Ho appena finito di leggere “Jazz”, di Toni Morrison.
Non ne sapevo niente: scrittrice afroamericana, premio Nobel 1992.
Una scrittura come nessuna letta prima.
Cercavo la musica del titolo e invece è la struttura del libro, sono gli assoli delle sue voci ad essere il jazz.
Difficile da seguire, ma a un certo punto non importa più accertarsi delle relazioni fra i personaggi che accompagnano la storia nè capire chi sta raccontando, perchè è la scrittura che guida.
Va letta con attenzione la “Prefazione”, che a me pare invece parte integrante del romanzo, come si vedrà nelle ultime pagine.
Io ne sono ancora un po’ stordito.